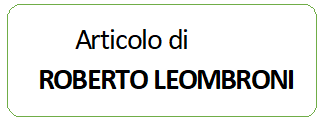 Come tutti i grandi eventi epocali, anche il dramma dell’emigrazione interna, in Italia, dei primi anni Sessanta, ben
Come tutti i grandi eventi epocali, anche il dramma dell’emigrazione interna, in Italia, dei primi anni Sessanta, ben  diversa da quella transoceanica dei primi del XX secolo, in quanto strettamente legata al boom economico, si riflette in numerosi testi musicali, in particolare in quelli prodotti dai cantanti più “impegnati”. Tra essi Il treno che viene dal sud (1966) di Sergio Endrigo, uno dei più celebri cantautori della “scuola genovese”, si richiama al cosiddetto treno di lu suli, che trasportava migliaia di emigranti italiani nelle aree europee più sviluppate. Si tratta di una delle tante canzoni, più o meno esplicitamente “politiche”, maturate nel nuovo clima musicale dei primi anni Sessanta, che trova proprio nei cantautori genovesi le sue espressioni più significative, e che, per dirla con il critico musicale Gianni Borgna, «rappresentano l’altra faccia del miracolo economico», quella «sofferta e, insieme, più vera». Il testo di Endrigo nasce come risposta polemica a un brano (La donna del sud, anch’esso del 1966) di Bruno Lauzi, sostanzialmente “disimpegnato”. Endrigo, al contrario, traducendo in versi poetici immagini tratte dal repertorio neorealista (si pensi a Rocco e i suoi fratelli), alterna il sentimento di dolore per l’abbandono della propria casa, della propria terra e dei propri cari al mesto stato d’animo dell’emigrante, nel quale si va sempre più assottigliando la speranza in un futuro migliore per sé e per la propria famiglia.
diversa da quella transoceanica dei primi del XX secolo, in quanto strettamente legata al boom economico, si riflette in numerosi testi musicali, in particolare in quelli prodotti dai cantanti più “impegnati”. Tra essi Il treno che viene dal sud (1966) di Sergio Endrigo, uno dei più celebri cantautori della “scuola genovese”, si richiama al cosiddetto treno di lu suli, che trasportava migliaia di emigranti italiani nelle aree europee più sviluppate. Si tratta di una delle tante canzoni, più o meno esplicitamente “politiche”, maturate nel nuovo clima musicale dei primi anni Sessanta, che trova proprio nei cantautori genovesi le sue espressioni più significative, e che, per dirla con il critico musicale Gianni Borgna, «rappresentano l’altra faccia del miracolo economico», quella «sofferta e, insieme, più vera». Il testo di Endrigo nasce come risposta polemica a un brano (La donna del sud, anch’esso del 1966) di Bruno Lauzi, sostanzialmente “disimpegnato”. Endrigo, al contrario, traducendo in versi poetici immagini tratte dal repertorio neorealista (si pensi a Rocco e i suoi fratelli), alterna il sentimento di dolore per l’abbandono della propria casa, della propria terra e dei propri cari al mesto stato d’animo dell’emigrante, nel quale si va sempre più assottigliando la speranza in un futuro migliore per sé e per la propria famiglia.
Il treno che viene dal sud
non porta soltanto Maria
con le labbra di corallo
e gli occhi grandi così.
Porta gente, gente nata fra gli ulivi,
porta gente che va a scordare il sole,
ma è caldo il pane lassù nel nord.
Nel treno che viene dal sud
sudori e mille valigie,
occhi neri di gelosia: arrivederci Maria!
Senza amore è più dura la fatica,
ma la notte è un sogno sempre uguale:
avrò una casa per te e per me.
Dal treno che viene dal sud
discendono uomini cupi
che hanno in tasca la speranza
ma in cuore sentono che questa nuova,
questa grande società,
questa nuova, bella società
non si farà, non si farà.
In termini molto simili, l’emigrazione compare nel testo di un altro cantautore genovese, Ciao amore ciao, una canzone composta da Luigi Tenco e presentata al Festival di Sanremo del 1967 insieme alla cantante francese Dalida. Essa nasce come riadattamento di una canzone antimilitarista (realizzata dallo stesso Tenco), Li vidi tornare, che, ispirata a La spigolatrice di Sapri di Luigi Mercantini, una delle più celebri poesie del nostro Risorgimento, parla di un manipolo di soldati reduci dalla guerra. Nella nuova versione di Ciao amore ciao, Tenco sintetizza invece il tradizionale tema dell’amore con quello della critica verso la società moderna, interpretando i sentimenti di un bracciante meridionale che, stanco del lavoro nei campi e allettato dal “miracolo economico”, decide di trasferirsi in una città del Nord (emblema del benessere e del consumismo, la cui immagine raggiunge le popolazioni meridionali soprattutto attraverso il nuovo medium televisivo), per cercare un lavoro stabile e costruire un progetto di vita. La canzone ricostruisce le varie fasi che accompagnano la scelta dell’emigrante: dall’iniziale insofferenza nei confronti della monotonia e dell’immobilismo che caratterizzano la vita rurale (“La solita strada...”) e del capriccio delle condizioni meteorologiche, da cui dipende la propria sopravvivenza (“Guardare ogni giorno se piove o c’è il sole...”) alla decisione di partire per “cercare un altro mondo”. Il prezzo da pagare però è piuttosto salato, in quanto egli deve lasciare nel paese d’origine la persona amata. Il contatto con la frenetica velocità della nuova realtà urbana (“Saltare cent’anni in un giorno solo...”) e l’alienazione metropolitana che scandisce la sua nuova esistenza producono inoltre in lui un effetto di “spaesamento” e di impotenza (“in un mondo di luci, sentirsi nessuno”), e la volontà di tornare indietro, frustrata tuttavia dall’assenza di denaro. Si tratta di un testo a suo modo “politico” che, in anni in cui anche la classe operaia è di nuovo in agitazione, esprime efficacemente la persistenza di zone di indigenza nel Meridione e il disagio giovanile di fronte all’ “altra faccia” del “miracolo economico”. Sarà proprio il suo insuccesso al Festival a provocare il suicidio del cantautore genovese, un evento che contribuirà a fare piazza pulita del mito della “spensieratezza” degli anni Sessanta, e a favorire la rapida trasformazione del cantautore stesso in una delle icone della nuova generazione sessantottina.
La solita strada, bianca come il sale
il grano da crescere, i campi da arare.
Guardare ogni giorno
se piove o c’e’ il sole,
per saper se domani
si vive o si muore
e un bel giorno dire basta e andare via.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.
Ciao amore,
ciao amore, ciao amore ciao.
Andare via lontano
a cercare un altro mondo
dire addio al cortile,
andarsene sognando.
E poi mille strade grigie come il fumo
in un mondo di luci sentirsi nessuno.
Saltare cent’anni in un giorno solo,
dai carri dei campi
agli aerei nel cielo.
E non capirci niente e aver voglia di tornare da te.
Ciao amore…
Non saper fare niente in un mondo che sa tutto
e non avere un soldo nemmeno per tornare.
Ciao amore…Nei precedenti testi di Endrigo e Tenco, pur indiscutibilmente animati dalla volontà di denunciare l’altra faccia del boom economico, manca tuttavia una specifica analisi nel merito delle cause politiche e sociali che hanno prodotto il fenomeno dell’emigrazione. Diverso è il caso di altre canzoni, composte da cantautori più direttamente impegnati nella lotta politica e sociale. Tra essi si distingue Ivan Della Mea, uno dei più combattivi esponenti della canzone di protesta degli anni Sessanta, tra gli animatori dell’etichetta I Dischi del Sole, che pone i propri testi al servizio delle grandi battaglie politiche e ideali. Della Mea è autore di Con la lettera del prete (1965), un brano che raffigura, con estremo realismo, e con un deciso piglio anti-clericale, il dramma dell’emigrazione interna. Qui, il tema dell’esodo in massa verso il Nord si intreccia con quelli altrettanto dolenti della “raccomandazione”, necessaria per lavorare, e degli incidenti sul lavoro, anch’essi espressione dell’altra faccia del “miracolo”. La versione della canzone (l’originale è in dialetto milanese) è di Riccardo Venturi.
Con la lettera del prete
è venuto qui a Milano
è venuto per lavorare
per fare i suoi quattro soldi.
Dài e dài un altro prete
gli ha trovato un bel lavoro
è andato a fare il muratore
per fare i suoi quattro soldi.
Dài lavora sei un terrone
dài lavora che tu sei forte
dài a Dio qualche soldo
per comprarti il tuo aldilà.
Il padrone gli disse:
“Per accordo con il prete
ti trattengo un tanto al mese
per la chiesa e la carità”.
È andato avanti stringendo i denti
per tre anni e quattro mesi
ha tirato su un bel po’ di chiese
col lavoro e la carità.
Dài lavora…
È cascato l’altro giorno
è scivolato dal campanile
è restato lì inchiodato
con le gambe paralizzate.
Con la lettera del prete
è tornato al suo paese
è andato via da Milano
è andato a vivere di carità.
Non lavori sei un terrone
con le gambe rotte e morte
con i soldi dati a Dio
hai comprato il tuo aldilà.
Quando suona la santa messa
giù al paese o il mattutino
lui è lì su di un gradino
a cercar la sua carità
lui è lì su di un gradino
a cercar la sua carità.
In pieno clima post-sessantottino, il tema dell’emigrazione assume un’ancor più marcata consapevolezza politica, come dimostra, in particolare, la Ballata dell’emigrazione (1970), composta dal cantautore veneziano Alberto D’Amico (una delle voci del Nuovo Canzoniere Italiano, e tra gli animatori del Canzoniere Popolare Veneto), ma più conosciuta nella versione di Giovanna Marini. Nata da una serie di incontri, che l’autore ha avuto con emigrati italiani nelle baracche alla periferia di Zurigo e di Berna, la canzone esprime, oltre alle condizioni umilianti sopportate in terra straniera (in questo caso la Svizzera) dai nostri emigranti, anche la loro volontà di riscatto e di cambiamento politico (“falce e martello ho messo all’elezione”), frustrata tuttavia dall’esito elettorale (“ha vinto la ruffiana del padrone”, ovvero la DC).
Quel giorno che so’ andato a settentrione
l’hai maledetto tanto, moglie mia
peggio però la disoccupazione
che dalla nostra terra non va via.
La Svizzera ci accoglie a braccia chiuse
ci mette un pane duro dentro in bocca
tre anni l’ho inghiottito ‘sto paese
tre anni carcerato alle baracche.
Alla periferia in mezzo ai fossi
siamo quaranta uomini e una radio
se vado in centro a fare quattro passi
le strade sono piene, piene d’odio.
Lo sfruttamento è calcolato bene
ci carica fatica ogni minuto
è un orologio di gran precisione
la Svizzera cammina col nostro fiato.
Sono ritornato al maggio per il voto
falce e martello ho messo all’elezione
noi comunisti abbiamo guadagnato
ma ha vinto la ruffiana del padrone.
Padroni sulla terra ci volete
per fare fame e fatiche tante
ma verrà il giorno che la pagherete
e che non partirà più un emigrante.
Nel 1974, ancora in anni di intense battaglie politiche e civili, il cantautore pisano Alfredo Bandelli compone la struggente canzone Partono gli emigranti. Qui compaiono due concetti strettamente legati alla nuova fase politica che l’Italia sta attraversando. Il primo è che l’emigrazione del dopoguerra è in parte anche conseguenza della discriminazione politica nei confronti dei lavoratori “sovversivi”, per lo più ex partigiani, militanti socialisti, comunisti o anarchici (“i deportati della borghesia” che partono “sotto lo sguardo della polizia”). Il secondo è che, a fronte dei disagi che l’emigrante deve sopportare (“fatica, violenza e razzismo”), la tristezza e la rassegnazione cedono il passo alla rabbia e alla volontà di lotta.
Non piangere oi bella se devo partire,
se devo restare lontano da te,
non piangere oi bella, non piangere mai
che presto, vedrai, ritorno da te.
Addio alla mia terra, addio alla mia casa,
addio a tutto quello che lascio quaggiù;
o tornerò presto, o non tornerò mai,
soltanto il ricordo io porto con me.
Partono gli emigranti, partono per l’Europa
sotto lo sguardo della polizia;
partono gli emigranti, partono per l’Europa
i deportati della borghesia.
Non piangere oi bella, non so quanto tempo
io devo restare a sudare quaggiù;
le notti son lunghe, non passano mai
e non posso mai averti per me.
Soltanto fatica, violenza e razzismo
ma questa miseria più forza ci dà;
e cresce la rabbia, e cresce la voglia
la voglia di avere il mondo per me.
Partono…

Commenti
RSS feed dei commenti di questo post.