di NANDO CIANCI A quei tempi c’erano due comportamenti che avevamo in spregio tanto noi ragazzi che i primi improvvisati allenatori: quello di correre tutti insiem e dietro al pallone e quello di passare la palla all’indietro. Il primo era segno di assenza di ogni idea e disciplina tattica: essere squadra, giocare insieme, significava anche garantirsi reciprocamente spazi per giocare al calcio e non essere costretti ad aggredirsi a vicenda in ogni momento. Il secondo rasentava la violazione dell’etica: passare la palla all’indietro era una sorta di vigliaccheria, di incapacità di affrontare a viso aperto (e non a spalle girate) l’avversario. Rappresentava, anche, l’assenza di abilità e la violazione di ogni logica: se lo scopo era quello di far gol, rimandare il pallone verso la propria difesa e il proprio portiere era negare l’essenza stessa del calcio. Anche nei grandi stadi, infatti, il pubblico fischiava sonoramente ogni passaggio verso il proprio portiere.
e dietro al pallone e quello di passare la palla all’indietro. Il primo era segno di assenza di ogni idea e disciplina tattica: essere squadra, giocare insieme, significava anche garantirsi reciprocamente spazi per giocare al calcio e non essere costretti ad aggredirsi a vicenda in ogni momento. Il secondo rasentava la violazione dell’etica: passare la palla all’indietro era una sorta di vigliaccheria, di incapacità di affrontare a viso aperto (e non a spalle girate) l’avversario. Rappresentava, anche, l’assenza di abilità e la violazione di ogni logica: se lo scopo era quello di far gol, rimandare il pallone verso la propria difesa e il proprio portiere era negare l’essenza stessa del calcio. Anche nei grandi stadi, infatti, il pubblico fischiava sonoramente ogni passaggio verso il proprio portiere.
 Come nella gran parte delle cose della vita, questi connotati “etici” sono stati rovesciati, negli ultimi decenni, nel loro contrario. Per esempio: oggi si vedono, soprattutto in Italia, partite in cui non c’è alcuna ariosità e 20 giocatori sono a lungo ammassati in una fascia di 20-30 metri, intenti più che altro a impedire all'avversario di fare gioco. Quanto ai passaggi all’indietro, essi prevalgono nettamente su tutte le altre modalità di gioco. Il che comporta che agli avversari si mostri più spesso la schiena che il volto. Detto a latere, non possono che sortirme partite noiosissime. A questo radicale cambiamento “etico” di uno sport ormai improntato su atletismo esasperato e su muscoli ai quali si richiede poca fantasia e nessuna creatività artistica corrisponde anche un mutamento profondo dei suoi “cantori”.
Come nella gran parte delle cose della vita, questi connotati “etici” sono stati rovesciati, negli ultimi decenni, nel loro contrario. Per esempio: oggi si vedono, soprattutto in Italia, partite in cui non c’è alcuna ariosità e 20 giocatori sono a lungo ammassati in una fascia di 20-30 metri, intenti più che altro a impedire all'avversario di fare gioco. Quanto ai passaggi all’indietro, essi prevalgono nettamente su tutte le altre modalità di gioco. Il che comporta che agli avversari si mostri più spesso la schiena che il volto. Detto a latere, non possono che sortirme partite noiosissime. A questo radicale cambiamento “etico” di uno sport ormai improntato su atletismo esasperato e su muscoli ai quali si richiede poca fantasia e nessuna creatività artistica corrisponde anche un mutamento profondo dei suoi “cantori”.
I radio-telecronisti succedutisi nella Rai per settant’anni, da Nicolò Carosio a Bruno Pizzul, parlavano un italiano forbito e popolare ad un tempo, con sobria e vigilata proprietà di linguaggio. Non pochi dei loro colleghi di oggi e dei cosiddetti “commentatori tecnici” che li affiancano, resterebbero muti davanti al microfono se togliessimo loro la possibilità di usare le quaranta o cinquanta parole gergali del tipo: cattiveria, determinazione, attaccare gli spazi, attaccare la profondità, assist … Alla cesellatura della parola che si incastra nel pallone in movimento e che accompagna il gesto “magico” di un tocco di piede o di un colpo di tacco o di una testata che imprime al pallone un movimento poetico si è sostituito l’ululato paranoico che sottolinea la pur minima parvenza di un’azione che si scosta di un millimetro dall’ordinario. Se poi la palla entra in rete, gli strilli sono talmente sguaiati ed incontrollati – spesso demenziali, nel senso non creativo della parola – che la compassione per il cronista e il commentatore si mischia al timore per la loro salute. Timore che svanisce quando ci si ricorda che ormai, nell’intrattenimento e nello spettacolo (e non solo in essi) siamo alla finzione della finzione. Va in scena un copione al quale i protagonisti non credono e che serve unicamente ad introdurre nelle orecchie e nell’animo dell’ascoltatore e spettatore la sensazione di star vivendo momenti epici irripetibili (in modo che possa continuare a sborsare denaro per parteciparvi). Come se qualcuno volesse commentare con i versi di Omero la propria personale impresa di aver imparato a lessare un uovo. Il parlare viene, così, infarcito di aggettivi esorbitanti ad ogni minimo gesto: una parata che per un portiere rappresenta il minimo sindacale (mezzo metro alla sua destra o sinistra) diventa “grande”, “eccezionale”, “miracolosa”. Uno Zoff lo avrebbe fatto con la massima nonchalance. Un passaggio di quelli che Rivera faceva solo quando era in forma scadente e collocava al grado più basso del suo repertorio diventa “sontuoso”; e così via. La grammatica e la sintassi, infine, non di rado vengono allegramente ignorate, quando non ingiuriate. Per fortuna, la tecnologia rende ora possib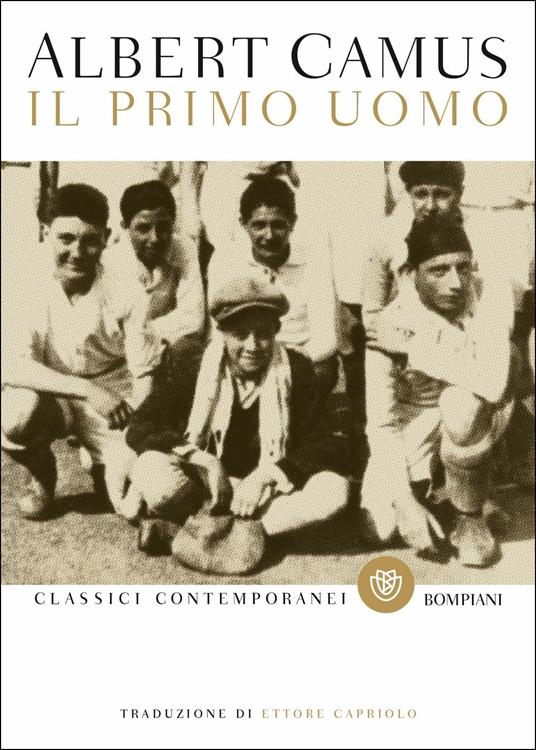 ile seguire le partite in tv con i soli suoni e rumori ambientali, escludendo le voci “narranti”. È uno dei casi in cui la tecnologia stessa aiuta ad elevare la qualità della vita.
ile seguire le partite in tv con i soli suoni e rumori ambientali, escludendo le voci “narranti”. È uno dei casi in cui la tecnologia stessa aiuta ad elevare la qualità della vita.
Il gioco del calcio, dunque, segue l’andamento culturale impresso a molti altri campi della convivenza umana. Del resto più volte esso è stato usato come stimolo a riflessioni più “impegnate”. Capita spesso di leggere che Jean Paul Sartre definì il calcio come «la metafora della vita». Albert Camus arrivò a dire che, «dopo tanti anni in cui il mondo mi ha concesso molte esperienze, ciò che so con maggiore certezza sulla moralità e sul dovere lo devo al calcio»[1]. Altri preferiscono definirlo come “metafora della guerra”[2]. Umberto Saba gli ha dedicato cinque note poesie[3]. Sul rapporto di Pasolini con il calcio molto si è scritto[4]. Il gioco, dunque, ci ha accompagnato anche in altri cambiamenti etici, simboleggiati da quelli che esso stesso ha subito. Non può sfuggire, per dire, il legame tra il progredire sempre più esasperato della competitività nell’economia e nella società con il fatto che la figura dell’arbitro all’inizio non esisteva ed ogni controversia doveva essere risolta in campo tra gentiluomini[5] e che si è progressivamente arrivati ad affidarsi ad un super-arbitro elettronico che ricontrolla la regolarità delle azioni di gioco. Così come l’idea che per primeggiare tutto sia lecito richiama al fatto che, alle origini del calcio, ogni comportamento sleale era vituperato come contrario al fairplay, mentre oggi si assiste a calciatori che si buttano a terra appena sentono il fruscio della gamba di un avversario, contorcendosi come colpiti a morte e rialzandosi disinvoltamente appena dopo aver scippato un calcio di punizione. E così via.
Tutto cambia, ci mancherebbe altro. E dunque anche i mutamenti in questo gioco si legano a tanti fattori,  culturali, di costume e di vario genere. E, come nella vita sociale l’umanità perde il ruolo di prim’attore per diventare sempre più un funzionario della tecnica, così nel calcio ormai il pallone e quel che di magico ed anche di artistico con esso si può fare ha perso la sua centralità perché i soldi che girano nel gran carrozzone sono di una quantità sterminata e lo soffocano. Il che comporta, come in tanti altri settori dello stare insieme, la prevalenza della frenesia per il risultato, lo scoraggiamento di ogni pausa di riflessione, l’insofferenza per la genialità creativa. I mezzi di informazione, pur di partecipare al trangugiamento della grande torta, fingono, come si è detto, di raccontare avvenimenti che non accadono. Insomma, in questo grande circo pecuniario, riesce sempre più difficile scorgere un pallone che rotola.
culturali, di costume e di vario genere. E, come nella vita sociale l’umanità perde il ruolo di prim’attore per diventare sempre più un funzionario della tecnica, così nel calcio ormai il pallone e quel che di magico ed anche di artistico con esso si può fare ha perso la sua centralità perché i soldi che girano nel gran carrozzone sono di una quantità sterminata e lo soffocano. Il che comporta, come in tanti altri settori dello stare insieme, la prevalenza della frenesia per il risultato, lo scoraggiamento di ogni pausa di riflessione, l’insofferenza per la genialità creativa. I mezzi di informazione, pur di partecipare al trangugiamento della grande torta, fingono, come si è detto, di raccontare avvenimenti che non accadono. Insomma, in questo grande circo pecuniario, riesce sempre più difficile scorgere un pallone che rotola.
[1] Camus giocò come portiere in una squadra dell’Algeria, sua terra natale, e le parole tra virgolette si possono leggere su un numero di France Football del 1957. Sartre, come è noto, si intrattenne sulla funzione dell’individuo in rapporto agli obbiettivi del gruppo nel gioco del calcio nella sua Critica della ragione dialettica (Teoria degli insiemi pratici, Libro II: Dal gruppo alla storia). Le citazioni delle parole di Sarte e Camus hanno qui un valore consapevolmente “suggestivo” e prescindono da una indagine sul contesto in cui vennero dette o scritte, nonché dall’insieme del pensiero degli autori.
[2] Per esempio Eduardo Galeano in Splendori e miserie del gioco del calcio, Sperling & Kupfer, Milano, 2000: «Nel calcio, rituale sublimazione della guerra, undici uomini in pantaloncini corti sono la spada del quartiere della città o della nazione. Questi guerrieri senza arma né corazza esorcizzano i demoni della folla e ne confermano la fede: a ogni confronto tra due squadre entrano in gioco vecchi odi e amori trasmessi in eredità dai padri ai figli» (p. 18).
[3] Squadra paesana, Tre momenti, Tredicesima partita, Fanciulli allo stadio, Goal.
[4] Cfr. ad esempio, in questo blog, Paolo Cianci, Centoventi vs Novecento, una partita da film (https://www.apassoduomo.it/index.php/rubriche/la-lepre-e-la-tartaruga/357-centoventi-vs-novecento-una-partita-da-film-2).
[5] Cfr. Antonio Papa, Guido Panico, Storia sociale del calcio in Italia, il Mulino, Bologna, 1993, p.13.