Bisogna approfondire la catastrofe – oggi più che mai – contro quella forma di storicismo che esalta il continuismo fine a se stesso: il mito di un progresso senza sosta, quale mera secolarizzazione (ormai inconsapevole per giunta) del plurimillenario “disegno della provvidenza”.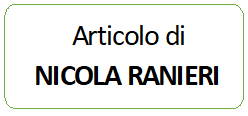 Bisogna arrestare ciò che è in movimento, per meglio vederlo, per scorgere il volto spesso patologico della Storia: le rovine su rovine accumulate da uno sfrenato sviluppo senza discernimento.
Bisogna arrestare ciò che è in movimento, per meglio vederlo, per scorgere il volto spesso patologico della Storia: le rovine su rovine accumulate da uno sfrenato sviluppo senza discernimento.
Pure la tradizione va rivista, con questa medesima ottica.
Se si smette di intenderla come un fiume che ora placido ora impetuoso scorre lungo il suo alveo, essa si mostra con ben altro volto: quello della discontinuità rispetto al continuum del succedersi degli avvenimenti. Infatti le rivoluzioni – il distruggere il vecchio affinché il nuovo sia possibile – sono necessarie per spezzare la tradizione ma anche per consapevolmente riscoprirla con altri occhi, rinnovandola, dopo aver passato a contrappelo la storia.
Talmente a contrappelo che perfino il patrimonio culturale accumulato lungo i secoli non lo si può pensare senza provarne orrore. Perché tale patrimonio esiste certamente per la fatica dei tanti geni che lo hanno creato ma, al contempo, per la schiavitù senza nome dei loro contemporanei. Tanto che esso non è mai un documento di cultura senza essere anche un documento di violenta barbarie. E dalla barbarie non è immune nemmeno la tradizione come, per converso, non lo è neppure quel conformismo che sta sempre in procinto di sopraffarla. A tal proposito, non può non venire alla mente la celebre poesia di Bertolt Brecht Domande di un lettore operaio, su chi fa la Storia: i vittoriosi che si coprono di gloria (in qualsiasi campo) o quelli che ne pagano le spese rimettendoci spesso la pelle?
A tal proposito, non può non venire alla mente la celebre poesia di Bertolt Brecht Domande di un lettore operaio, su chi fa la Storia: i vittoriosi che si coprono di gloria (in qualsiasi campo) o quelli che ne pagano le spese rimettendoci spesso la pelle?
Vi è, insomma, tra il poeta-drammaturgo e il filosofo una così stretta affinità che il secondo afferma in chiave teoretica ciò che il primo esprime in versi.
L’amicizia fra questi due grandi intellettuali tedeschi è tale per cui Benjamin, influenzato da Brecht, rinsalda il proprio anti-soggettivismo come freno al misticismo, o a quel che György Lukács definisce ateismo religioso, poiché messianico. Un freno, che lo accomuna a Brecht anche nel coltivare un sobrio nichilismo, come ponte di passaggio al comunismo, dopo il suo giovanile pensiero anarchico-rivoluzionario espresso nel saggio Per la critica della violenza, e ispirato sia da Georges Sorel sia dall’atmosfera del Primo dopo guerra.
Le Tesi di filosofia della storia, invece, manifestano il suo pensiero della maturità, si schierano contro la visione socialdemocratica e a favore della lotta di classe.
La quale però non consiste in una prova di forza per decidere chi vince o chi perde, e nemmeno nella presunta certezza che tutto andrà bene per il vincitore e male per il vinto, poiché di sicuro la classe borghese – che vinca o soccomba nella lotta – è condannata comunque a perire, a causa delle inevitabili contraddizioni crescenti entro lo stesso meccanismo dello sviluppo economico.  Il punto essenziale è dunque il seguente: perirà di propria mano o per mano del proletariato?
Il punto essenziale è dunque il seguente: perirà di propria mano o per mano del proletariato?
Nel primo caso, la sua fine coinciderà con la distruzione totale delle condizioni di umana sopravvivenza. Nel secondo caso, alla lotta del proletariato spetta il compito di tagliare (per così dire) il filo che brucia prima che arrivi alla dinamite. Prima che tutto sia perduto.
In altre parole. La lotta del proletariato, nel mentre combatte lo sfruttamento, è anche una sorta di rivoluzionario freno d’emergenza per salvare l’umanità dalla distruzione o, più precisamente, dal meccanismo economico che la origina. Il capitalismo infatti – avendo per carattere il culto dell’accumulo fine a se stesso e del dio denaro – è destinato a provocare ovunque sfruttamento, guerra, rovina e distruzione; sempre, ovviamente, in nome del progresso e del benessere che (con somma ipocrisia) a tutti va promettendo in ogni angolo del pianeta.
Oggi poi, nell’epoca dell’imperante neoliberismo che è il vero totalitarismo in chiave economicistica – ma sedicente democratico ed esportatore di diritti –, torna attuale più che mai la critica radicale di Benjamin alla visione socialdemocratica. Poiché questa non è il freno di emergenza che possa interrompere il folle andare verso il disastro totale. Anzi, essa è così vuotamente progressista da farsi del tutto simile al sistema economico che produce solo rovine su rovine.
La visione socialdemocratica è infatti compromissoria, accomodante fino a scomparire e assimilarsi totalmente al neoliberismo economicistico- tecnicistico; fino a esserne la giustificazione politica e ideologica. A tal punto che oggi riformismo vuol dire solo riforme – controriforme! – imposte dal totalitarismo liberistico, per distruggere quel barlume di diritti conquistati in anni lontani, attraverso lotte anche violente.
tecnicistico; fino a esserne la giustificazione politica e ideologica. A tal punto che oggi riformismo vuol dire solo riforme – controriforme! – imposte dal totalitarismo liberistico, per distruggere quel barlume di diritti conquistati in anni lontani, attraverso lotte anche violente.
Non a caso Walter Benjamin rammemorava, come vero tentativo rivoluzionario, il brevissimo momento della Lega di Spartaco che nel 1919 venne repressa nel sangue dalle milizie dei Corpi Franchi, per decisione del ministro Gustav Noske e con la complicità del cancelliere Friedrich Ebert, entrambi socialdemocratici.
Gli spartachisti intendevano contribuire a liberare dalla schiavitù tutti gli oppressi, in base all’idea marxiana secondo cui la classe schiava è la vendicatrice che porta a termine la liberazione in nome anche delle passate generazioni di vinti. E può portarla a termine perché, divenendo il soggetto della conoscenza storica e avendone chiara coscienza, può liberare se stessa dalle catene dell’oppressione.
È questo il senso profondo del pensiero politico di Benjamin, ispirato dall’esempio spartachista: l’urgenza della rivoluzione sorge nel presente e si nutre anche di una lunga tradizione di lotte degli oppressi, affinché non siano state vane e la loro speranza (direbbe Bloch) non sia tramontata per sempre. Bisogna quindi riprendere il passato, in maniera tale però che la ripetizione non si disperda nell’eterno ritorno ma divenga un intreccio esplosivo di tempo mitico, tempo storico e tempo della fine: del non ancora o della redenzione. Insomma una autentica creazione rivoluzionaria, sia individuale sia collettiva, in cui ragione ed ebbrezza (in senso surrealista) si congiungano per far saltare una determinata epoca dal corso omogeneo della storia.
Una rivoluzione che, invece di rimuovere la catastrofe, sorga proprio dalla visione delle rovine, e immagini – sulla scia di Rosa Luxemburg – il socialismo come radicale alternativa alla barbarie che produce rovine d’ogni genere. E non solo materiali!
L’alienazione, infatti, attecchisce nella ripetitività ossessiva, nei forsennati meccanismi di produzione, nel costrittivo lavoro estraniante o perfino nel tempo libero posto sotto lo stesso segno e, massimamente, nel ridurre tutto a merce: a partire dal lavoratore.
Senza la cui presa di coscienza nessuna rivoluzione proletaria è possibile.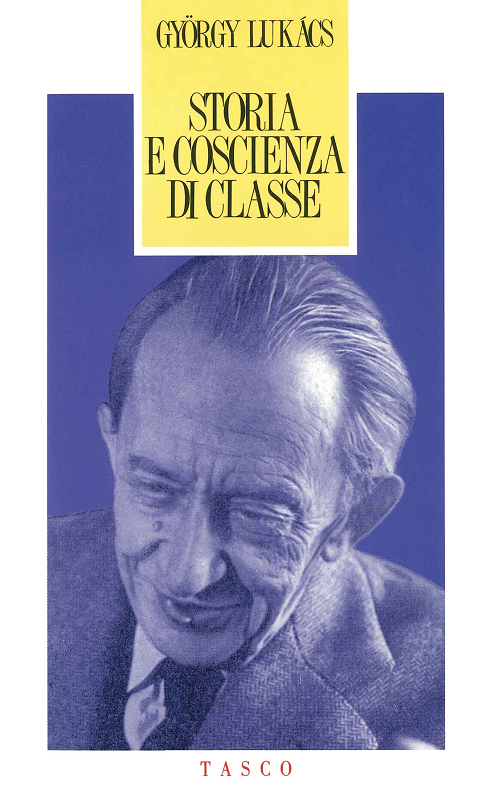 Proprio per questo, in Benjamin, è decisivo l’influsso (come lo è per tanti altri e particolarmente per la cultura critica francofortese) di Storia e coscienza di classe di Lukács. Secondo il quale la reificazione – siccome consiste nel ridurre ciascuno a mera forza lavoro, a merce, a una cosa appunto – diviene un fenomeno universale, che perciò coinvolge le modalità dell’organizzazione e della vita sociale nonché del pensiero e della vita psichica.
Proprio per questo, in Benjamin, è decisivo l’influsso (come lo è per tanti altri e particolarmente per la cultura critica francofortese) di Storia e coscienza di classe di Lukács. Secondo il quale la reificazione – siccome consiste nel ridurre ciascuno a mera forza lavoro, a merce, a una cosa appunto – diviene un fenomeno universale, che perciò coinvolge le modalità dell’organizzazione e della vita sociale nonché del pensiero e della vita psichica.
Del resto, è ciò di cui Marx scrive nel paragrafo Il carattere di feticcio della merce e il suo arcano; non facendone però materia del solo primo capitolo quanto piuttosto di tutto Il Capitale. Che peraltro costituisce il coerente sviluppo dei giovanili Manoscritti economico-filosofici. Già in essi Marx considera l’oggettivazione come il modo in cui l’uomo realizza se stesso attraverso il lavoro, e considera l’alienazione come la forma che questa oggettivazione assume nella vita di fabbrica, dove l’operaio vien reso estraneo a se stesso con la privazione della propria essenza di uomo.
Oggi la vita di tutti – tecnologicamente e scientisticamente organizzata com’è secondo criteri aziendalistici – risulta estranea a se medesima, in balia della alienazione totale, della nevrosi collettiva quale somma di quella dei singoli elevata all’ennesima potenza.
Sicché, nell’epoca dell’uomo a una dimensione, miliardi di nuovi schiavi dovrebbero avere coscienza di classe e lottare uniti contro un siffatto sistema di sfruttamento. Ma sono inebetiti ad arte dalla martellante propaganda dell’acquisto a portata di tutte le tasche, dalle sirene che spingono ciascuno a sentirsi imprenditore di se medesimo – ovvero uno schiavo felice che nemmeno lontanamente intravede la possibilità di perseguire un radicale cambiamento collettivo.
Perciò, non essendoci coscienza di classe, il sistema capitalistico difficilmente perirà per mano di un proletariato che non sa di esser tale.
Perisce invece, progressivamente, di propria mano e per la terrificante catastrofe planetaria che è destinato a produrre in virtù del suo originario carattere, del suo costitutivo esser fatto solo per andare avanti – senza potersi mai voltare indietro – solo per inseguire lo sviluppo dissennato, giacché ognora sospinto dal religioso dogma di un ottuso progressismo, che è il meccanico rovescio del “provvidenzialistico” quanto illusorio “disegno salvifico”.
(3. fine)
La foto di Bertolt Brecht è flickr.com (CC BY-NC-ND 2.0)
Per leggere la prima parte cliccare qui
Per leggere la seconda parte cliccare qui
