Il materialismo storico ha bisogno – per vincere nella lotta di classe – di prendere al suo servizio la teologia, così da poter scorgere una prospettiva messianica.
È questo, in estrema sintesi, il significato della prima delle diciotto Tesi di filosofia della storia di cui si compone l’ultimo testo (postumo) di Walter Benjamin, redatto agli inizi del 1940 pochi mesi prima del suicidio a Port Bou, sul confine spagnolo, per non finire in mano ai nazisti che occupavano la 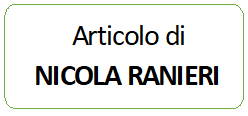 vicinissima Francia. Mentre lo scriveva, ignorava ovviamente che fosse anche il suo testamento. Si trattava comunque di una sorta di bilancio anche del senso dell’esistere, contraddistinto dall’idea di felicità nella quale vibra indissolubilmente l’idea di redenzione.
vicinissima Francia. Mentre lo scriveva, ignorava ovviamente che fosse anche il suo testamento. Si trattava comunque di una sorta di bilancio anche del senso dell’esistere, contraddistinto dall’idea di felicità nella quale vibra indissolubilmente l’idea di redenzione.
L’intero testo costituisce perciò una profonda riflessione sulla prospettiva a venire – intimamente radicata nel passato individu ale e collettivo – sulla rappresentazione del passato: che è il compito della storia.
ale e collettivo – sulla rappresentazione del passato: che è il compito della storia.
Ma il passato reca con sé un indicatore segreto che lo rimanda alla redenzione.
Appunto per questo, vi è una segreta intesa fra le generazioni passate e la nostra: noi siamo stati attesi sulla terra, perché eravamo la loro speranza. A noi, come ad ogni generazione che ci ha preceduto, è stata data in dote una debole forza messianica su cui il passato ha un diritto. È un’esigenza, questa, difficile da soddisfare. Ma il materialista storico non può non tenerne conto, giacché è la più importante nella prospettiva di una umanità redenta. Per la quale il passato – ognuno dei suoi attimi – diventa fondamentale alla luce del giorno finale o del giudizio.
Sotto la cenere del passato, dell’arcaico, del mito, della fiaba – della memoria involontaria, tanto prossima all’oblio – si conserva e si nasconde la brace del futuro. Talché l’illuminazione – la rivelazione – si sprigiona dal contatto fra questi due estremi del tempo, dato che l’arcaico e il dimenticato nel profondo di noi sono (anche secondo Freud e Jung) sempre presenti, sia nel singolo sia nella collettività. E dunque, uno choc o la rottura di una tradizione nel momento del pericolo li fanno risorgere.
Di qui la necessità di fare del presente una esperienza originaria: per così ritrovare il futuro nel passato in maniera che essi si congiungano nell’ora in cui scocca la scintilla che dischiude la porta della redenzione o della felicità.
La felicità, infatti, nasce dalla perdita, perché solo ciò che è perduto resta eterno (dice Benjamin in una lettera giovanile, citando il finale del IV atto del Brand di Ibsen). Perciò solo il recupero, il riscatto, la redenzione – il ricomprare quel che era nostro – rendono possibile la felicità. Se però la si intende unicamente in chiave individuale, essa si muta in sgomento, in quanto il recupero di quel che è perduto presuppone la nostalgia e dunque: o un rimpianto senza oggetto o un qualcosa di indefinibile.
Se invece il recupero significa riscatto collettivo, vuol dire che i vinti di ieri si battono ora (attraverso di noi) per la redenzione, ovvero contro la storia scritta dai vincitori che li hanno espropriati di ciò che a loro apparteneva. Se così viene intesa, la nostalgia riscopre e trasforma ciò che era perduto in oggetto ritrovato e foriero di felicità non solo individuale, sotto il segno di un messianismo del tutto secolarizzato.
Del resto, lo scopo primario della lotta di classe è quello di battersi per ottenere cose materiali. Perché, senza di esse, quelle spirituali nemmeno esisterebbero. Tuttavia, pure queste sono presenti nella lotta. A tal punto presenti da fornirle quegli elementi essenziali – fiducia, coraggio, umore, astuzia, impassibilità – che agiscono in essa retroattivamente, spingendola a farsi carico financo dei tempi più lontani, in modo tale da rimettere in discussione ogni vittoria dei dominatori nel corso degli anni o dei secoli. Perciò: come i fiori volgono il capo verso il sole così – in forza di un eliotropismo segreto – tutto quel che è stato tende a volgersi verso il sole che sta salendo nel cielo della Storia.
Perciò: come i fiori volgono il capo verso il sole così – in forza di un eliotropismo segreto – tutto quel che è stato tende a volgersi verso il sole che sta salendo nel cielo della Storia.
Di cotanta forza trasformatrice deve avere chiara consapevolezza il materialista storico.
Il quale – diversamente da chi articola il passato solo per conoscerlo come è stato o secondo la Storia scritta dai vincitori – deve saper cogliere l’elemento di discontinuità, che balena in un attimo e indica una dimensione temporale di libertà davvero rivoluzionaria, in rottura con l’ottimismo linearmente progressivo affinché, attraverso la tensione che viene a crearsi, ogni istante divenga la piccola porta da cui può entrare il messia.
Bisogna, insomma, spezzare la linearità del tempo con il tempo della fine o dell’apocalisse. In ciò Walter Benjamin e Simone Weil (sebbene con motivazioni diverse) erano concordi nell’attaccare la visione della Storia come linearità.
Oggi l’Occidente, che già per loro negli Anni Trenta del secolo scorso aveva toccato un punto di non ritorno, ha perduto qualsiasi idea di rivoluzione, di futuro liberato, che non sia una semplice estensione potenziata del presente, secondo una visione fatta di tecnologie sempre più avanzate e di un economicismo utilitaristico volto solamente all’accumulo fine a se stesso e a una infinita crescita virulenta come la peggiore delle malattie.
Benjamin (oggi più che mai) ribadirebbe la necessità di un salto apocalittico, di uno svelarsi del presente e del passato al soggetto storico nel momento del massimo pericolo. In ogni epoca, infatti, bisogna strappare la tradizione al conformismo che è in procinto di sopraffarla. Perché il messia non viene solo come redentore, ma come vincitore dell’Anticristo. Solo così (a suo giudizio) il messia storico ha il dono di accendere nella rappresentazione del passato e, quindi, del presente la favilla della speranza. Perciò il suo pensiero ha molto in comune con quello di Ernst Bloch, che concepisce la storia alla luce del principio speranza: simile a un continuo trascendere proteso verso il non ancora: simile a un religioso principio eversivamente utopico: simile al marxiano sogno di una cosa. Ossia quella antica – mistica e mitica – aspirazione umanissima alla autorealizzazione e alla felicità.
Perciò il suo pensiero ha molto in comune con quello di Ernst Bloch, che concepisce la storia alla luce del principio speranza: simile a un continuo trascendere proteso verso il non ancora: simile a un religioso principio eversivamente utopico: simile al marxiano sogno di una cosa. Ossia quella antica – mistica e mitica – aspirazione umanissima alla autorealizzazione e alla felicità.
E però, affinché possa inverarsi, l’aspirazione deve trasformarsi in sogno in avanti (secondo Bloch), in un desiderio a cui segua l’azione rivoluzionaria, che a sua volta presuppone il risvegliarsi della coscienza: talmente in grado di riformare se stessa da diventare coscienza di classe nonché dell’intreccio dialettico di passato, presente e futuro.
Anche Benjamin parla di un vero e proprio risveglio, di un sogno ad occhi così spalancati da riuscire a vedere-immaginare la catastrofe, il capo-volgimento totale.
Il suo Angelo della Storia infatti – ispirato al quadro Angelus Novus di Paul Klee – ha il viso rivolto al passato, in cui non vede una catena di eventi, bensì una sola catastrofe immane che accumula senza tregua rovine su rovine.
Egli vorrebbe trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma dal paradiso spira una così forte tempesta che le sue ali restano aperte, sicché irresistibilmente viene spinto nell’ignoto futuro a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui fino al cielo.
Ciò che chiamiamo progresso è niente altro che questa tempesta.
(2.continua)
Le foto di Benjamin, Weil e Bloch risultano di pubblico dominio.
