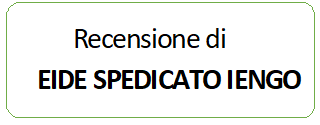
Ci sono libri che scorrono veloci sotto gli occhi, e libri che si assaporano con calma per apprezzarne il contenuto, lo stile, il timbro, la costruzione dell’impianto, l’eleganza della scrittura. Ci sono, insomma, libri “dell’ora”, per dirla con John Ruskin, che si lasciano inghiottire senza lasciare traccia di sé e libri che tornano ad essere sfogliati e riletti.
Lo snello, serrato e insieme polposo romanzo di Nicola Di Tullio, che qui si commenta, appartiene a questa seconda categoria per almeno tre motivi. Innanzitutto, perché le sue pagine, costruite su venticinque capitoli brevi (qualcuno brevissimo) si servono di una forma del narrare realistica e coinvolgente che prende per mano il lettore inducendolo a partecipare ai dialoghi, agli ambienti, alle situazioni che si descrivono quasi si assistesse ai quadri di un testo teatrale o alle scene di un film neorealista (come, peraltro, precisa nella raffinata post-fazione Plinio Perilli). Poi, perché indugiano su quelle espressioni esistenziali che insegnano a dare un senso alle cose, anche alle esperienze più gravose come la tragicità della guerra che rovescia il senso comune e sposta situazioni, sentimenti, percezioni dal loro assetto normale. Infine, perché sollecitano a confidare nella rinascita anche quando tutto sembra instabile, compromesso, sfilacciato, perduto.
La storia di Santina – che si svolge in quella parte dell’Abruzzo che fu palcoscenico di una delle pagine più sanguinose e drammatiche del secondo conflitto mondiale, di quella guerra totale fatta sempre delle stesse tragedie anche dal punto di vista visivo- si fa pretesto per raccontare una piccola/grande storia in cui il sentimento e la ragione instaurano fra loro un dialogo faticosissimo per governare gli smarrimenti e lo straniamento di abitare quotidianità irragionevolmente travagliate, sospese, desertificate. Corre l’obbligo di precisare che la guerra aveva stretto un legame particolare con il territorio che qui si racconta. «Non si era risparmiata in niente, non aveva nascosto niente di sé. Non era una guerra riconoscibile in quella raccontata da coloro che ne avevano conosciute altre ed avevano avuto la fortuna di tornare a casa e farne un racconto. Questa era entrata in casa, si era messa a nudo in tutta la sua essenza e, per non farsi dimenticare, quando era stata costretta a spostarsi, aveva lasciato qua e là qualcosa di sé che la tenesse viva. Il fronte era passato, si era spostato in avanti. Si sarebbe detto che la guerra era finita, ma la guerra era presente e non solo nel ricordo. C’erano ancora soldati. C’era l’essenza di ciò che si era portata via e c’era tutto quello che aveva lasciato. Anche qualche mina in attesa di essere urtata per aver modo di liberare la sua ferocia inespressa e repressa» (p.23) e, così, cancellare un cognome dal registro dell’anagrafe o un soprannome di famiglia.
È, dunque, in questo paesaggio -non più teatro di scontri bellici in cui la vita cominciava faticosamente a riprendere le sue regole e i suoi tempi, compresi quelli delle lacrime e dei funerali (la guerra aveva sospeso anche quelli)- che si svolge la storia di Santina. Una storia che il destino orienta in direzione di scelte e tracciati esistenziali altri, diversi da quelli codificati nella comunità a maglie strette di cui era figlia, a motivo della presenza in paese di un soldato con il turbante e la barba.
Il paese, va precisato, era abituato alla presenza dei soldati, anche di quelli reclutati in India e arruolati fra le truppe britanniche degli Alleati e pure di quelli con il turbante e la barba. «Non davano nell’occhio, non si distingueva uno dagli altri in una medesima uniforme militare, con turbante e barba, soprattutto a vederli a distanza. Un turbante non era diverso da un altro turbante, una barba da un’altra barba. Ma quell’indiano appostato in quel punto di osservazione non dava la sensazione che fosse, più di una volta, lì per caso. Sempre lui, lo stesso che si era visto nella celebrazione della messa prima in una casa e poi in un’altra e di cui si era avvertita la presenza a distanza durante il ritorno di Santina e della zia a casa. Non c’era dubbio, lo stesso» (p.28).
Va da sé che quel soldato «in atteggiamento di attesa nello stesso posto o almeno in atteggiamento che non aveva l’aria di una solita attività di servizio di un soldato» (p.29) preludeva l’arrivo di qualche guaio e la replica di fatti già accaduti. «La guerra –precisa l’Autore- aveva insegnato che non sono da aspettarsi troppe differenze tra coloro che la fanno e non è da attendersi di trovarvi uno meno peggio di un altro» (p.28). Pertanto, in paese, quel soldato cominciò ben presto a promuovere e alimentare congetture, sospetti, fantasie, inquietudini, occhiate che non avevano bisogno di parole per alludere, supporre, commentare. Il passaggio della guerra, assieme alle rovine, alle case diroccate, alle famiglie dimezzate o cancellate, spesso portava con sé anche il pianto di bambini non previsti, bambini dai tratti e dalla pelle diversi, bambini non nati, bambini nati e scomparsi.
Ma per Santina e il soldato indiano Sultan il destino, come accennato, aveva scritto ben altro copione. Un copione a lieto fine: con la guerra sullo sfondo, due storie parallele che si incontrano, si rivelano e decidono, non senza inciampi, di scriverne una sola. La storia di Santina e di Sultan (p.109).
Non è dato sapere se questa vicenda attenga a un fatto realmente accaduto o sia un’invenzione dell’Autore. L’interrogativo può rimanere senza risposta: è ininfluente. Importante, invece, è sottolineare che la storia di Santina e di Sultan, oltre a tematizzare quelle correnti emozionali, quegli arsenali espressivi, quelle costanti della vita che appartengono alla Storia dell’uomo, accompagna nella lettura di un tempo anteriore che merita riguardo e di essere, se non tesaurizzato, almeno conosciuto, come dimostrano le pagine sulla cornice sociale ed etica di questa storia.
Penso, qui, per esempio, a quelle che si aprono su realtà familiari e nebulose parentali costruite sul valore della lealtà e delle obbligazioni reciproche; a quelle che riproducono i brusii, le voci, le espressioni del controllo sociale di cui si alimentava la vita paesana; a quelle che alludono alle confidenze sussurrate con pudore, agli sguardi e ai silenzi che dicono più delle parole (come quelle che si scambiano Matalena e comare Giacinta quando le visite di Sultan nella casa di Santina si fanno tanto frequenti da non passare inosservate). Ma penso anche alle pagine che disegnano i profili netti, solidi, protettivi dei protagonisti e dei comprimari di questo mondo: quello di Quintino (lo zio di Santina), di don Francesco (parroco di una chiesa a cielo aperto, colma di macerie), di Vitangelo che sapeva appianare liti e controversie e, non di rado, chiudere «la bocca senza remissione anche alle gelosie avvelenate tra cognate, che con le loro lingue lunghe istigavano ad odi per la vita insanabili di fratello contro fratello» (p.35). E ancora: penso alle pagine che si soffermano sullo stravagante Medeo che, pur non avendo dimestichezza con le parole trova, tuttavia, quelle giuste per replicare alle perplessità suscitate in paese dalla volontà di Santina di sposare Sultan e seguirlo in patria. Medeo nel modo che gli è proprio, di uomo di campagna qual è, sentenzia che quella scelta è giusta, esattamente come sono giuste le stagioni: «In un ramo, anche indurito durante l’inverno, il gonfiore dilata e ingrossa la corteccia, e la gemma, quando è il suo tempo, sboccia. Quando è tempo, è tempo. Non va a chiedere il permesso alla guerra, nemmeno alla guerra. La natura ha i suoi precetti. […] Non si possono cambiare le stagioni. Ognuna arriva quando è tempo che arrivi, non va certo a comando. Quando è primavera, è primavera […]» (pp.61-62). Pertanto anche quella di Santina deve seguire il suo corso: a nulla vale opporvisi. Da ultimo, a conferma della sensibilità e dell’abilità narrativa dell’Autore, penso in particolare alle pagine che, in punta di penna, descrivono le emozioni che prova Santina all’idea della sua vita a venire «in un mondo di cui non sapeva niente, se non che era il mondo da cui veniva Sultan» (p.55); a quelle che si soffermano sull’operosità altruista del parroco, don Francesco, per rendere possibile un matrimonio all’apparenza impossibile; a quelle che insistono sugli smarrimenti del protagonista del romanzo, Quintino, di fronte all’oscenità, alle contraddizioni, alle implicazioni della guerra e alla matassa di pensieri che sembrano aver perso la parola.
Molto altro, ovviamente, potrebbe aggiungersi intorno a questo libro ricco di sfumature e di richiami alla letteratura “alta”, ma è tempo di chiudere per lasciare al lettore il piacere di coglierne il senso in modo autonomo, senza suggerimenti. Non posso, tuttavia, esimermi dall’annotare che questa vicenda che documenta la parte più intima di un sentire individuale e collettivo, sembra voler suggerire che non vale nascondere e soffocare le proprie incertezze, le proprie inquietudini, insomma la propria fragilità. La fragilità non è un difetto. È, all’opposto, una strategia che abitua a sguardi più misurati e a scelte più consapevoli anche se esigono prezzi da pagare. Il testo, non per caso, si chiude con le lacrime che la partenza di Santina provoca in chi l’ha conosciuta e vista crescere. Le lacrime scorrono anche sulle guance del ruvido zio Quintino che le ha fatto da padre. Ma, in questo caso, “è bello piangere” e le lacrime non vanno soffocate, perché come quelle di Filumena Marturano nel dramma di Eduardo De Filippo, accompagnano in favole che si realizzano.
.
