Marco Ferreri a buon diritto può essere considerato alla stregua di altri grandi registi italiani quali Rossellini, Antonioni, Fellini, Pasolini.
Da giovanissimo esordì come produttore e promotore cinematografico, aiutando nel 1950 Michelangelo Antonioni a ottenere i finanziamenti per Cronaca di un amore, 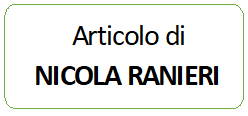 la prima opera di finzione dopo la fase dei cortometraggi documentaristici. Dei quali Ferreri era così entusiasta da sentirsi fortemente motivato a realizzare tra il 1958 e il 1960, in Spagna, quei suoi primi tre film sceneggiati prevalentemente da Rafael Azcona – El pisito, Los chicos, El cochecito – di sicura impronta neorealistica ma con un carattere tipicamente spagnolo, il grottesco: la esasperazione degli elementi realistici, ossia una vera e propria deformazione del reale all’interno della satira “cattivamente” provocatoria e pungente che diviene uno dei tratti essenziali del suo cinema. Perciò fin da subito la censura si accanisce su di lui, a partire da L’ape regina e La donna scimmia, i primi due film girati dopo il rientro in Italia. I quali, pur richiamandosi (anche a suo dire) a un impianto neorealistico in senso lato e da commedia all’italiana, sono nondimeno venati di una originalissima comicità: causticamente grottesca e impregnata di humor nero tendente a divenire freddezza analitica dei comportamenti patologici o, meglio, analitica della patologica normalità, osservata col crudele cinismo di uno sguardo clinico somigliante, non già a quello del medico, bensì del veterinario mancato – come Ferreri stesso amava definirsi. Un “veterinario” tutto preso a indagare il sostrato animale, e persino mostruoso, intrinsecamente annidato nel fondo di una umanità che, quanto più crede di essersene liberata, tanto più ne è posseduta. Infatti, ne L’harem (1967), i maschi ridiventano così mostruosamente belluini che si coalizzano contro la protagonista femminile per ucciderla, facendola precipitare da una scogliera.
la prima opera di finzione dopo la fase dei cortometraggi documentaristici. Dei quali Ferreri era così entusiasta da sentirsi fortemente motivato a realizzare tra il 1958 e il 1960, in Spagna, quei suoi primi tre film sceneggiati prevalentemente da Rafael Azcona – El pisito, Los chicos, El cochecito – di sicura impronta neorealistica ma con un carattere tipicamente spagnolo, il grottesco: la esasperazione degli elementi realistici, ossia una vera e propria deformazione del reale all’interno della satira “cattivamente” provocatoria e pungente che diviene uno dei tratti essenziali del suo cinema. Perciò fin da subito la censura si accanisce su di lui, a partire da L’ape regina e La donna scimmia, i primi due film girati dopo il rientro in Italia. I quali, pur richiamandosi (anche a suo dire) a un impianto neorealistico in senso lato e da commedia all’italiana, sono nondimeno venati di una originalissima comicità: causticamente grottesca e impregnata di humor nero tendente a divenire freddezza analitica dei comportamenti patologici o, meglio, analitica della patologica normalità, osservata col crudele cinismo di uno sguardo clinico somigliante, non già a quello del medico, bensì del veterinario mancato – come Ferreri stesso amava definirsi. Un “veterinario” tutto preso a indagare il sostrato animale, e persino mostruoso, intrinsecamente annidato nel fondo di una umanità che, quanto più crede di essersene liberata, tanto più ne è posseduta. Infatti, ne L’harem (1967), i maschi ridiventano così mostruosamente belluini che si coalizzano contro la protagonista femminile per ucciderla, facendola precipitare da una scogliera.
In altre parole: il regista – entro una struttura narrativa “forte” o cosiddetta “classica” o non ancora compiutamente “moderna” – trasforma la iniziale osservazione realistica, la estremizza, la deforma fino al grottesco e perviene a una realtà più profonda, al nocciolo stesso dei rapporti di coppia, famigliari e di sopraffazione.
Riesce pertanto a compiere un passaggio ulteriore, tra il 1963 e il 1969, con la realizzazione travagliatissima (per motivi finanziari e di censura) de L’uomo dei cinque palloni il cui secondo titolo è Break-up, in apparenza per omaggiare Blow-up di Michelangelo Antonioni, in realtà per sfruttarne commercialmente il successo da parte del produttore Carlo Ponti.
Ferreri rimaneggiò più volte questa sua sofferta opera, poiché la riteneva di capitale importanza entro il cammino evolutivo della propria poetica. E difatti oggi, a più di mezzo secolo dalla versione definitiva e a un quarto di secolo dalla morte del suo autore, molti sono coloro che ne riconoscono la grandezza geniale da cui essa scaturì: da un’idea, in fondo, tanto banale quanto fertilissima da mettere in moto una vicenda certamente paradossale, ma paradossale spesse volte lo è pure la realtà – a detta dello stesso regista.
È la storia di Mario, l’agiato proprietario di una fabbrica di dolciumi, che sta per sposarsi con Giovanna. La ripetitiva piattezza della sua vita – sia professionale sia sentimentale – viene scossa all’improvviso (come sovente capita) da un fatto di nessuna importanza. Mentre raccoglie un palloncino gonfiabile, di quelli utilizzati dalla sua ditta a fini pubblicitari, gli accade di chiedersi quale sia il punto esatto del gonfiaggio un istante prima che esso esploda. Sembra una domanda da nulla. Che però pone una serie di interrogativi, per rispondere ai quali si rivolge, con ansia, perfino ad alcuni esperti.
Quanta aria si deve soffiare per tendere al massimo la gomma del palloncino?
Come la si può misurare con precisione – una simile quantità – al momento che precede il violento strappo?
Se è misurabile, vuol dire che lui può sapere con certezza fin dove spingersi quando soffia l’aria dei suoi polmoni nella evanescente pellicola di gomma senza che questa esploda?
Gli balena così nella mente l’idea di limite – di soglia! – di passaggio al limite o di salto nel vuoto: nel caos.
Un caos analogo a quello che gli capita di provare nel corso di una festa, di un vero e proprio happening in cui il forsennato crescendo sonoro-visivo gli appare in forma di una onirica apoteosi del regno della ingovernabilità, ovvero della temutissima irrazionalità che lo atterrisce; lo ossessiona talmente tanto da far esplodere le sue innumerevoli manie. Ché, se prima le considerava alla stregua di innocui giochetti solitari – o in compagnia della sua Giovanna –, ora gli si trasformano nell’inferno compulsivo-maniacale della depersonalizzazione, di un alienarsi da se medesimo e del sopraggiungere di una inesorabile quanto lucidissima follia, che lo spinge al suicidio.
Del resto, un diverso approdo forse non potrebbe mai darsi per uno come Mario: ossessionato com’egli è dalla precisione, dalla meticolosa calcolabilità, dal limite e da un oscuro desiderio di oltrepassarlo; ma con il terrore del fallimento a cui (a suo giudizio) il senza-limiti necessariamente conduce.
Cosicché questa storia di un palloncino trovato per caso – ma gonfiato con l’intento di sperimentare fino a che punto possa spingersi lo sperimentatore nell’insufflare aria senza che si verifichi lo scoppio, o il passaggio al limite – pone un problema apparentemente semplice ma dalle complesse implicazioni scientifico-tecniche. Che, a loro volta, ingenerano in chi ne è l’artefice (o piuttosto il succubo di tanta complicatezza) una dilemmatica ossessione compulsivo-maniacale che lo conduce alla follia. L’ingegnere e industriale Mario Fuggetta è, infatti, il protagonista di vicende le cui caratteristiche assumono le sembianze allegoriche di un apologo beffardamente ironico sulla alienazione nella società industriale degli Anni Sessanta e successivi. Perché un simile apologo si presenta quale racconto esemplarmente emblematico del borghese in quanto tale: chiuso nella solitudine di massa e perversamente votato a un ansiogeno gioco che consiste nello studio scientifico-tecnico dell’azzardo per trarne profitto ma con addosso la paura del fallimento ognora in agguato. È questo il dissennato trastullo tormentoso della sua vita, come della intera società capitalistica.
Talmente lo sovrasta la paura che, contro di essa, Mario erige il fortificato argine della perfezione, del controllo di tutto, sia della vita professionale sia di quella sentimentale. In maniera che dal controllo sortisca un continuo miglioramento sentimentale – possibilmente – ma soprattutto produttivo per abbassare i costi e aumentare il capitale, spingendosi sempre più in là nel gioco d’azzardo, evitando però di superare quel limite oltre il quale rischierebbe di perdere tutto, di entrare nella sfera del non quantificabile, nell’aborrito caos in cui nulla è più controllabile - né la sua donna né la fabbrica - nemmeno il se stesso che, perduta ogni certezza, si depersonalizza fino alla alienazione totale.
