
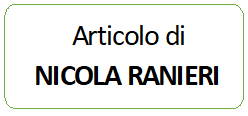 Jiří Menzel (1938-2022) si formò nella celebre Accademia cinematografica FAMU di Praga, frequentata tra il 1950 e il 1970 da futuri registi come lui e Vera Chytilova, Miloš Forman, Dušan Makavejev o (in anni più recenti) dal bosniaco-serbo Emir Kusturica – un bravissimo allievo proprio di Menzel. Il quale, diplomatosi con un mediometraggio narrativo e divenuto docente all’Accademia, si era rivelato (sin da poco più che ventenne) non solo un singolare regista promettente ma pure un talentoso attore nonché autore di un episodio degno di nota del film collettivo Perline sul fondo, considerato il manifesto della nouvelle vague cecoslovacca. In un episodio del successivo film collettivo Delitto nella scuola femminile aveva spostato l’attenzione sul tema del sesso, tratteggiandolo però con ironia e scanzonata leggerezza.
Jiří Menzel (1938-2022) si formò nella celebre Accademia cinematografica FAMU di Praga, frequentata tra il 1950 e il 1970 da futuri registi come lui e Vera Chytilova, Miloš Forman, Dušan Makavejev o (in anni più recenti) dal bosniaco-serbo Emir Kusturica – un bravissimo allievo proprio di Menzel. Il quale, diplomatosi con un mediometraggio narrativo e divenuto docente all’Accademia, si era rivelato (sin da poco più che ventenne) non solo un singolare regista promettente ma pure un talentoso attore nonché autore di un episodio degno di nota del film collettivo Perline sul fondo, considerato il manifesto della nouvelle vague cecoslovacca. In un episodio del successivo film collettivo Delitto nella scuola femminile aveva spostato l’attenzione sul tema del sesso, tratteggiandolo però con ironia e scanzonata leggerezza.
Ma l’opera prima con cui raggiunse la notorietà internazionale è Treni strettamente sorvegliati (1966) che, fra i tanti premi e riconoscimenti, vinse due anni dopo l’Oscar come miglior film straniero.
Si tratta di una storia in cui la virilità di un giovanotto insicuro risulta a tal punto problematica da indurlo a tentare il suicidio tagliandosi le vene nella vasca da bagno di un albergo. Tuttavia, salvato appena in tempo dalla morte, egli trova (anche con l’aiuto degli altri) il coraggio di superare timori e fallimenti, attraverso la liberazione sessuale e la presa di coscienza sociale e politica. Un coraggio che lo rende viepiù sicuro e virilmente capace di compiere un grande gesto eversivo: far saltare per aria uno di quei treni tedeschi – strettamente sorvegliati dai nazisti invasori – in transito nella stazione del suo piccolo paese. Ed è un’impresa ancor più eroica perché compiuta da un ex-imbranato quasi del tutto simile al Buon soldato Sc’vèik di Jaroslav Hasek, a cui il film si ispira fin dalle prime sequenze. Infatti, una musica marzialmente solenne fa da contrappunto alla vestizione del giovane, come fosse un generale. Invece, ha solo superato l’esame per diventare vice capo del movimento alla stazione. E la madre, vestendolo, gli dice di tenere alto l’onore dei suoi antenati (che in realtà erano degli scansafatiche) e di quanto sia bello, mentre lui si pavoneggia con la divisa, la borsa in mano e con in testa il cappello col fregio.
Questo e altri film del grande regista praghese hanno i tratti della desolazione, dell’ironia, del grottesco, dell’assurdo ma pure della levità caustica e beffarda, giacché son mossi da un sentire profondo – intriso di accenti talvolta rabbiosi – che lo porta a vedere il reale con occhi sapienti poiché imbevuti di uno sguardo tanto teatrale quanto letterario, ispirato com’è alle storie dello scrittore Bohumil Hrabal, suo sceneggiatore di fiducia.
Il tutto però gli deriva dal fastidio, da una vera rivolta interiore nei confronti della politica, della censura e dell’ottusità burocratica del regime socialista a cui poi e per un certo periodo finisce per piegarsi – tra il 1970 e il 1989. Un ventennio durante il quale sull’intera generazione della Nova Vlna cecoslovacca scende la cappa della repressione e i suoi esponenti di spicco vengono schedati nella lista nera.
Nel 1990 – tra la caduta del muro di Berlino, la dissoluzione dell’URSS e la rivoluzione cecoslovacca – Jiří Menzel vince l’Orso d’oro al festival di Berlino per Allodole sul filo, che però è un film del 1969 (su soggetto di Hrabal) ambientato in un paese fuori Praga sul finire degli Anni Quaranta in un campo di lavoro per la rieducazione dei dissidenti. Come in tutte le opere di Menzel, attraverso le piccole storie di paese traluce la grande Storia . Appunto per questo la occhiuta repressione del regime la sequestra per venti anni. Duranti i quali Menzel resiste con ostinazione ai carri armati e alla censura. Non scappa in America, come Miloš Forman e altri. Poi ricomincia da zero, armato più che mai di caustica ironia e coadiuvato da uno  sceneggiatore come Hrabal, nel fermo convincimento che l’espressione della poetica non debba tendere alla autoreferenzialità, ma si lasci creativamente guidare dall’intento di realizzare piccoli film che piacciano al pubblico e, al contempo, non facciano vergognare lui di fronte alla grandezza letteraria dello stimato Hrabal, col quale ha lavorato fin da giovanissimo alla realizzazione de La morte del signor Baltazar (1965).
sceneggiatore come Hrabal, nel fermo convincimento che l’espressione della poetica non debba tendere alla autoreferenzialità, ma si lasci creativamente guidare dall’intento di realizzare piccoli film che piacciano al pubblico e, al contempo, non facciano vergognare lui di fronte alla grandezza letteraria dello stimato Hrabal, col quale ha lavorato fin da giovanissimo alla realizzazione de La morte del signor Baltazar (1965).
Così tanto – e da sempre – preferisce tenersi lontano dalla autorialità che ironizza su chi «si inventa un film, se lo scrive da solo, da solo se lo gira e, poi, pure da solo se lo guarda».
Treni strettamente sorvegliati ha il tono e la struttura di un piccolo film che può piacere al pubblico (del resto, l’Oscar lo si vince anche a condizione che il botteghino tiri).
È un breve romanzo di formazione del vice capo del movimento Miloš Hrma – ambientato nel 1945, in una stazioncina della Boemia occupata dai nazisti.
Max, il capostazione, anziché sorvegliare strettamente i treni, si dedica molto alle faccende domestiche e quasi per nulla a quelle lavorative.
Miloš elegge a modello di virilità il responsabile del servizio Hubicka: una sorta di dongiovanni che, da esperto in vicende amorose, potrebbe insegnargli il modo per raggiungere la sicurezza in campo sessuale o, più concretamente, il metodo per vincere l’eiaculazione precoce che gli impedisce di congiungersi carnalmente con Máša, la ragazza che ama riamato. Così forte è il bisogno d’aiuto che lo va chiedendo a chiunque gli ispiri fiducia, anche alla insoddisfatta moglie di Max, il capostazione moralista che (come tutti i moralisti) livorosamente condanna e invidia i successi amorosi del suo caposervizio che si intrattiene con una procace cugina che lui stesso però si dà a corteggiare, nel mentre lamenta la degenerazione dei costumi e vien richiamato all’ordine dalla moglie. Alla quale peraltro non dispiacerebbe aiutare il giovane insicuro a risolvere un problema così capitale per lui. Tant’è che da un lato si schermisce alla sua richiesta d’aiuto, dall’altro gli parla e nel frattempo continua a ingozzare di cibo un’oca accarezzandone il lungo collo con dolcissime mani vigorose sotto il voglioso sguardo di Miloš, che darebbe chissà cosa per ricevere da lei un simile trattamento sapientemente carezzevole.
Il film è disseminato di episodi erotici, carichi di sensualità, di giochi allusivi ad altro e altro ancora, di doppi sensi che stuzzicano la curiosità morbosa di questi paesani tanto repressi quanto in preda a desideri lascivi. Sicché Hubicka – diversamente da quel libertino immorale che sembra essere ai loro occhi – rappresenta, per paradosso, la figura di una profonda moralità ironica e sferzante contro il fariseismo e l’ipocrisia degli asserviti collaborazionisti.
Questi bigotti d’ogni risma si venderebbero l’anima pur di vogliosamente sapere i pornografici particolari delle notturne tresche (all’interno dell’ufficio) fra il caposervizio e la telegrafista, condotti in tribunale dalla madre della giovanissima Zdenka quando scopre sulle cosce e i glutei della figlia le timbrature impresse da Hubicka con i timbri statali.
In realtà, si è trattato di un eroticissimo gioco ilare, ironico e beffardo, vissuto gustosamente da entrambi come una sarcastica irrisione dell’ottuso burocratismo legalistico che ammanta l’illegalità, il perbenismo ipocrita, il servilismo dei collaborazionisti infami del regime poliziesco e spietato la cui emblematica figura è Zednicek: l’ispettore generale, che suscita in Max un ardente desiderio di emularlo facendosi promuovere da capostazione a ispettore, appunto.
Hubicka invece – come lo zio di Máša, un altro personaggio a suo modo opposto all’immoralità dei moralisti e servi di ogni regime – incarna non solo il contrario di una simile mentalità, ma è pure colui che intende contribuire a risolvere l’angosciante problema di Miloš. Chiede perciò un concretissimo aiuto a Viktoria Frei, la staffetta partigiana che arriva la sera prima con l’esplosivo per il sabotaggio del giorno dopo al treno tedesco carico di munizioni. Lei – rivoluzionaria, femminista e femminile – accetta volentieri di passare le ore notturne insegnando al ragazzo (ardentemente desideroso di apprendere) l’arte di calmarsi, di ascoltare in profondità il proprio corpo insieme al corpo di lei. Ma soprattutto, l’opera pedagogica può compiutamente giungere a buon fine perché già l’ouverture sdrammatizza all’improvviso tutte le giovanili apprensioni di lui con una irrefrenabile risata di entrambi, suscitata da un fatto imprevisto. Mentre sul divano dell’ufficio stanno per accingersi all’impresa, lei, allungando una gamba, con il tacco della scarpa sbadatamente allarga lo strappo nella pelle del divano viennese che ha assistito nel corso del tempo a molte grandi manovre amorose. Ridendo di gusto, si abbracciano e danno inizio con calma e profondo sentire a un connubio che, in virtù di un sanissimo ridere liberatorio, li rende intimi da estranei che erano fino a un attimo prima.
All’indomani, Miloš Hrma (il cui cognome vuol dire, guarda caso, “Monte di Venere”) si sente come rinato e pronto a compiere l’eroica impresa.
Acquattato sull’alto traliccio che sostiene il semaforo, attende il passaggio del lungo treno che trasporta armamenti e truppe. Quando se lo ritrova disotto, butta la cassetta – con l’esplosivo innescato – proprio su un vagone carico di munizioni. Ma, non appena tenta di rialzarsi calmo e soddisfatto, un soldato tedesco addetto alla sorveglianza lo vede e spara da una cabina del vagone successivo… lui, come un uccello in volo, cade stecchito sul telo che copre le munizioni.
Con uno spaventoso boato, il treno deflagra poco più in là della stazione. Tant’è che si rompono i vetri delle finestre e lo spostamento d’aria sballotta cose e persone, anche Máša, sopraggiunta proprio in quell’istante per abbracciare l’amato Miloš.
Del quale, però, rimane solo il cappello col fregio. A lei riportato, in dono e in memoria, dal vento.
