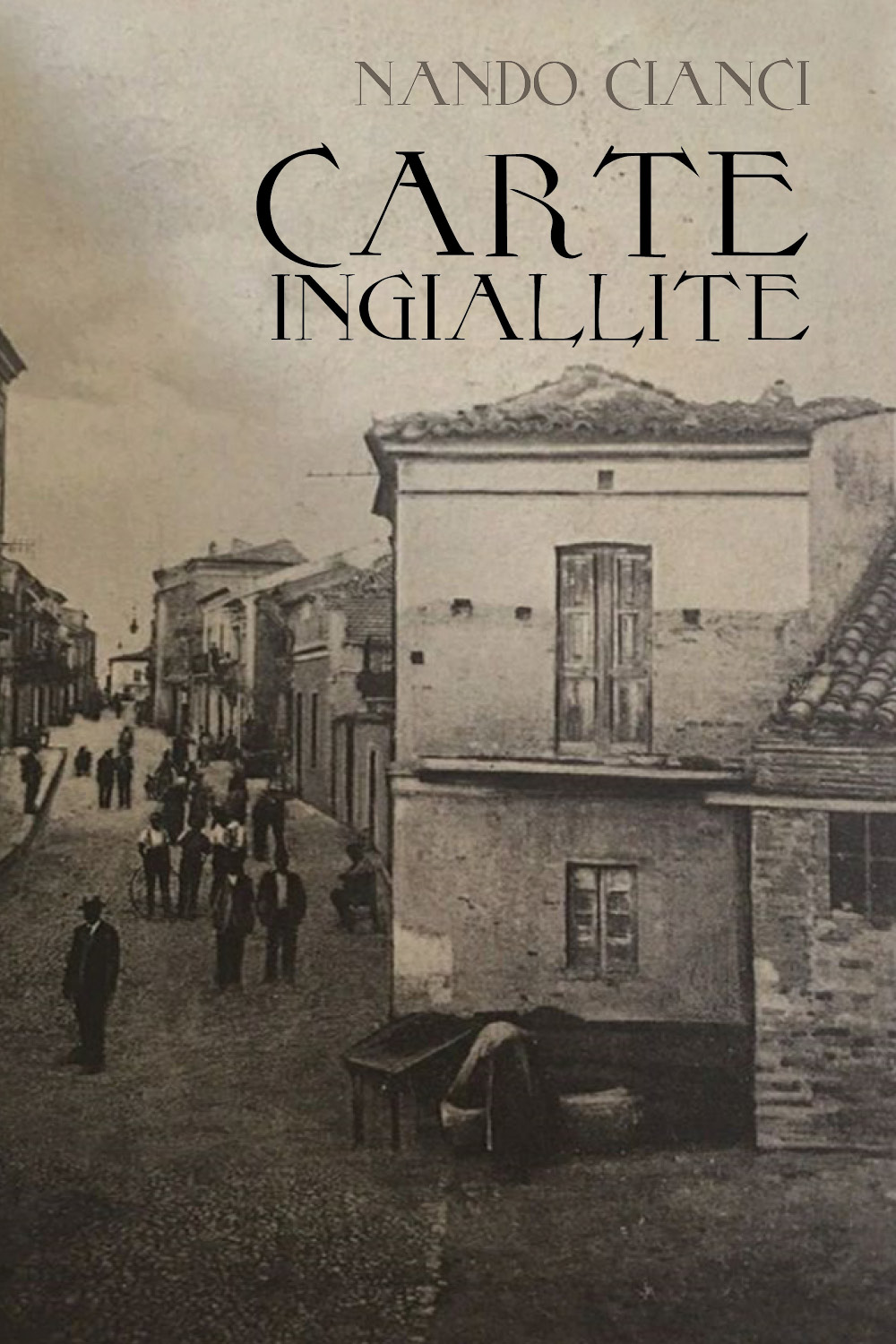 Carte ingiallite, di Nando Cianci, Youcanprint, Lecce, 2019, pp. 110, € 10,00.
Carte ingiallite, di Nando Cianci, Youcanprint, Lecce, 2019, pp. 110, € 10,00.
«Un libro che, sullo sfondo dei cambiamenti storici e sociali del Paese, rispolvera volti, nomi, ambienti, esistenze, mentalità».
Recensione
di EIDE SPEDICATO IENGO.
Il contenuto di questo libro (come peraltro suggerito dal suo titolo) rinvia ad ambienti e situazioni d’altri tempi; a corredi materiali e immateriali indebitamente marginalizzati; a prassi naufragate. Ma rinvia anche e soprattutto al concetto di tempo come kairos, ossia come spazio di riflessione, parole, memorie, pensieri, scelte. In tempi in cui dominano l’impazienza, la chiacchiera, la sedentarietà del pensiero, il solipsismo sociale, la concentrazione sulla bolla di un presente sempre più inconsapevole e smemorato, questo testo che vuole tutelare il giusto ritmo della memoria, dell’immaginazione, dei sentimenti è dunque, e per più di un verso, provocatorio. O, più opportunamente, è un libro “contro”. Contro l’idolatria di un fare che ha espunto da sé ogni forma di introspezione e di autonomia del giudizio; contro l’intrappolamento nella omologazione culturale; contro la cultura del rumore e delle parole urlate e assertive; contro gli sguardi riduttivi e autoreferenziali; contro il pensiero ridotto a strumento di produzione; contro la compressione e l’opacizzazione degli universi simbolici. Insomma, “contro” alcuni dei vizi più vistosi della nostra contemporaneità. Ma entriamo in qualche dato di dettaglio.
Attraverso alcuni eventi del passato, raccolti vuoi spulciando fra le pagine di vecchi giornali, vuoi riecheggiando i racconti ascoltati dagli anziani, vuoi attingendo alla propria memoria, Nando Cianci allestisce uno snello inventario di accadimenti pubblici e privati e, sullo sfondo dei cambiamenti storici e sociali del Paese, rispolvera volti, nomi, ambienti, esistenze, mentalità. Il risultato è una sorta di diario parlato o, meglio, una cronaca retrospettiva di eventi, esperienze, ricordi in cui non ci sono tesi obbligate da difendere o schemi da seguire, ma solo l’invito a riconoscersi in una storia comune e, così, promuovere il passaggio dalla cultura vissuta in forma spontanea e talora acritica alla cultura riflessa, analizzata, ricostruita intellettualmente.
Per esempio, le pagine dedicate alla figura del generale Giuseppe Salvatore Pianell, inviato da Francesco II di Borbone a prevenire e scoraggiare il proposito rivoluzionario dei garibaldini in Abruzzo, lasciano emergere sulla società del tempo quelle costanti italiche tuttora vitali, quali l’opportunismo, l’inerzia nella pratica sociale, l’orientamento alla negoziazione, il trasformismo, insomma l’anemia del capitale civico. Anche la lettura delle testate giornalistiche abruzzesi sull’ascesa del Partito Nazionale Fascista conferma (sebbene non mancassero voci dissenzienti) quell’orientamento alla prudenza, quel timore conformistico, quelle espressioni di reverenza al potere, quell’opportunismo diffuso e praticato tipico di una realtà sociale imbrigliata in angustie e personalismi, incapace di assumere una robusta personalità collettiva.
Scorrendo il testo, una particolare attenzione si coglie nelle pagine che danno voce al fare dell’uomo e al recupero dei suoi più diversi percorsi espressivi. Questo cambio di passo si fa evidente, per esempio, nei capitoli sulla guerra: sulla Grande Guerra prima e poi su quella che, per dirla con Miriam Mafai, «è entrata in ogni casa» e ha trasformato «città e villaggi in campi di battaglia» (M. Mafai, Pane nero, Mondadori, 1987, p.4). Quelle quotidianità (lontane) di violenza, di fame, di paure, di angosce, di fughe, di distruzione, di prigionia, di spaesamenti e straniazioni di cose e persone, in cui talora il nemico mostra una faccia amica e gli amici ti sparano addosso, prendono vita attraverso le parole di chi quegli eventi ha vissuto sulla propria pelle. Quei testimoni che oggi non ci sono più riprendono, così, a raccontarsi e a raccontare con la logica schietta e rettilinea della gente semplice un altrove che rivive con la fedeltà di un’inchiesta.
Anche nelle pagine dedicate all’emigrazione in Svizzera, quantunque riguardino gli anni Ottanta del Novecento, si riaffaccia nuovamente il tema della straniazione. Una condizione che, anche in questo caso, destabilizza, espropria, esilia, abitua a compromessi e mimetismi e disegna, non certo da ultimo, identità civiche a metà che pesano soprattutto sulle seconde e sulle terze generazioni di emigranti. Esattamente come avviene oggi, per esempio, nel nostro Paese in cui la convivenza fra diversi manca tuttora di un quadro di regole certe, univoche, condivise in grado di incoraggiare istanze dialogiche, riconoscimenti reciproci, incontri alla pari, in cui ogni cultura deve (dovrebbe) presentarsi non solo per parlare, ma anche per ascoltare.
Nel capitolo conclusivo, a mio parere “da antologia”, l’Autore intrattiene un suo dialogo personale con il Tempo, del quale mette in scena non il volto negativo che sottrae e consuma, ma quello positivo, in apertura che arricchisce, educa alla consapevolezza, alla coerenza, alla tutela dei sentimenti, compresi quelli che si vestono di fragilità e di nostalgia. In questo modo al concetto di tempo come kairos (accennato ad inizio di questa nota) si aggiunge quello di aion, ovvero l’espressione del tempo che, pur passando, lascia i segni di una ricca fertilità.
In queste pagine i ricordi si infittiscono e premono per essere raccontati. Hanno molto da dire perché riguardano una generazione che, essendo nata e vissuta nella seconda metà del Novecento, ha attraversato in tempi assai brevi non anni ma epoche e mondi, come correttamente viene precisato: «il dopoguerra, la sobrietà, il boom economico, la stagione delle lotte sociali, il riflusso, l’indebolirsi delle ancore del pensiero». Ovvero, una generazione che ha avuto in sorte di abitare un tempo sfaccettato, plurale, fitto di contrasti: prima lento e rettilineo, poi sempre più impaziente, inquieto, contraddittorio, spaesante che, comunque, ha lasciato in eredità a chi l’ha vissuto un grappolo di valori che contano (possono contare) nel percorso esistenziale: la responsabilità e il senso del dovere, per esempio; la fedeltà agli impegni presi; l’autodeterminazione; la capacità di praticare la pazienza, la sobrietà, l’equilibrio, la solidarietà, tanto per citarne alcuni.
È forse proprio questo corredo valoriale che non teme, in chi lo possiede, di aprire la porta alla tenerezza dei ricordi, compresi quelli che fanno male perché richiamano alla memoria quotidianità gravose e travagliate, quando per esempio la povertà -che significava abiti laceri, bambini scalzi, pasti che non saziavano- trovava, comunque, ricetto nello spazio imbozzolante della comunità che non commiserava ma aiutava. Queste pagine, dunque, introducono in scenari che appaiono oggi remoti ma che in anni, neppure tanto lontani, erano vivi e vitali. Quando, per esempio, esisteva il vicinato e, nelle case, la chiave era sempre nella toppa dalla parte della strada. Quando d’inverno, la brace dei camini accesi era di tutti e ciascuno, se non ne aveva, poteva prenderla dal suo vicino. Quando ci si alimentava con poco, ma si sedeva tutti alla stessa mensa e gli sprechi alimentari erano una realtà sconosciuta. Quando la merenda si faceva nella casa in cui ci si trovava, perché i bambini erano figli di tutti e la genitorialità sociale, come si dice oggi, non costituiva una rarità. Quando i ragazzini giocavano per strada e l’allegria diventava palpabile. Quando i giorni festivi si annusavano, avvolti com’erano nel soffice cosmo dei messaggi olfattivi, in quegli odori della cucina materna che alludevano ai gesti attenti di mani virtuose ma, per contrappunto, anche alla desolante vuotezza di molti stomaci. Quando di notte si vedevano le stelle e saliva inevitabile la commozione per l’infinità dell’universo e la piccolezza umana. Quando, a primavera, la terra sprigionava lenta e sensuale la vita e l’adolescenza scopriva la magia delle prime, timide, tenere, impacciate, inespresse forme di innamoramento. «Sentivamo la fragranza dell’odore di una ragazza e temevamo di sciuparla toccandola» viene annotato con delicatezza. Quando la vita comunitaria era segnata dal libero commercio dei rapporti faccia a faccia e nessuno era escluso, neppure quelle signore comuni, «quelle mamme di famiglia, spesso in precedenza abbandonate dai mariti, che respingevano l’indigenza confortando una varia umanità frustrata e bisognosa d’affetto […] in cambio, diciamo così, di un tozzo di pane. Lo facevano quando non trovavano lavoro “a giornata” nei campi o al servizio di qualche famiglia facoltosa». Quando nessuna cosa era superflua e niente veniva sciupato: se cadeva una mollica di pane per terra, veniva raccolta, baciata e portata alla bocca. Quando anche di notte si girava tranquilli e ci si aspettava di incontrare solo volti amici. Quando anche gli spiriti, che popolavano i racconti degli anziani e facevano un po’ paura, insegnavano comunque il coraggio di accompagnarsi all’ignoto, di andare incontro alla vita e di non temerne le inevitabili inquietudini. Quando, insomma, si viveva con ritmo umano.
Ovviamente molto altro ancora raccontano queste pagine eleganti e convincenti, ma è tempo di chiudere. Rischierei, diversamente, di scivolare nella nicchia dei miei ricordi e aggiungerli a quelli che ho appena commentato. Il che contravverrebbe alla struttura di una recensione. Ma in queste pagine, che lo si voglia o no, ci si riconosce. Sono contagiose: creano doppi, analogie, legami, appartenenze, comunità. Invitano, insomma, ad agire e, in particolare, a prestare attenzione al futuro.
Un futuro che, all’opposto, sembra essere l’ultimo dei pensieri di questa nostra società sempre meno abitabile, frivola, smemorata, gregaria, a rimorchio di ogni novità. Non si leggano, perciò, in veste di rimpianto di piccole patrie o paradisi perduti (peraltro mai esistiti): si avvicinino, invece, come un modo per correggere gli errori e le apatie dell’oggi. Per tenere a mente che ciascuno di noi è nel mondo sia come erede del proprio passato, sia come soggetto che agisce, valuta, sceglie. Coltivare i ricordi è, pertanto, azione dinamica e generativa, serve a guardare avanti. Ad allertare, per esempio, che continuiamo insensatamente ad allevare un presente sciatto, obeso, vacuo, egoista, rancoroso, eticamente anemico, che non sa intravedere una qualsivoglia immagine di futuro.