Capita qualche volta – o spesso, magari – che per un autore degno di questo nome l’opera inizi dove quella precedente finiva. Ovviamente non sempre e non a tutti succede allo stesso modo. Ma se e quando in taluni avviene, ecco che le loro opere si concatenano l’una all’altra come un evolutivo intrecciarsi del medesimo discorso. Il quale in sé le contiene e con grande coerenza, sia pure con le necessarie variazioni e le digressioni 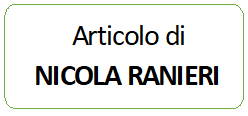 che, nel mentre sembrano persino incongrue, sono in realtà differenti maniere di ampliare e approfondire una stessa temperie ideativo-espressiva del pensiero e del sentire poetico congiunti entrambi in un rigoroso e personale sguardo sincero sul mondo: sia esterno sia interiore.
che, nel mentre sembrano persino incongrue, sono in realtà differenti maniere di ampliare e approfondire una stessa temperie ideativo-espressiva del pensiero e del sentire poetico congiunti entrambi in un rigoroso e personale sguardo sincero sul mondo: sia esterno sia interiore.
Marco Ferreri ne è un fulgido esempio.
Tra Dillinger è morto (1969) e La cagna (1972) gira due film, Il seme dell’uomo e L’udienza, certamente diversi fra di essi e anche dal precedente, eppure, nonostante il primo di questi ultimi due digredisca da Dillinger, innegabilmente ne prosegue gli intenti fondamentali, addirittura li rafforza, mostrando come la volontà autodistruttiva dell’uomo alienato risulti così pervicacemente tale da liberare, alla fine, l’intero pianeta dalla propria ingombrante presenza. Infatti, soltanto i manichini di plastica – allineati lungo la riva di un mare morto – restano quale traccia dell’umano passaggio sulla terra.
Tuttavia l’opera in cui la continuazione si mostra evidentissima è La cagna.
Questo film, non solo comincia dove Dillinger è morto terminava, ma il regista sembra dire a se stesso e al riguardante: proviamo a trasformare quel finale – quella improbabile fuga a bordo di un sinistro veliero – in un nuovo inizio, in un riaprirsi della prospettiva.
Supponiamo che quel protagonista sia davvero approdato a Tahiti oppure, se non proprio nei Mari del Sud, magari a un’isola meno lontana ma pressoché disabitata.
Supponiamo che, invece di Glauco, egli si chiami Giorgio (figurandosi però di essere Robinson Crusoe) e abbia come unica compagnia un cane di nome Melampo, con il quale se ne stia appollaiato sull’alto di una roccia a bearsi nel vedere e sentire le onde spumeggianti sotto la sferza del vento.
Supponiamo, altresì, che abiti in una sorta di igloo in cemento armato e che indossi pure degli occhiali eschimesi; che viva in totale solitudine e si ritrovi come sospeso tra il primordiale e il post-atomico; che si sforzi anche di continuare a disegnare e dipingere storie immaginarie, accompagnandole con il fischiettare in sordina (a mo’ di sussurro a se medesimo) una vecchia canzone massimamente emblematica del mito dei Mari del Sud, Creola. Ebbene, proprio il tenersi compagnia sussurrandosela all’infinito, oppure ascoltandone ossessivamente la versione strumentale dal giradischi, gli riconferma in maniera assillante ciò da cui va fuggendo. Ovvero il suo inestirpabile desiderio di rapporto con la donna: sia in chiave esotica, sia come musa ispiratrice e sia in funzione autoironica sul proprio continuo voler cercare l’impossibile o l’altrove d’ogni cosa. Cioè tutto quello che lui crede di aver trovato ritirandosi su un’isola disabitata nelle Bocche di Bonifacio, ove il tempo – sospeso e come immobile – si ripete senza variazioni di sorta, entro uno spazio ristretto in cui la pace appare tanto raggiunta quanto improbabile.
Un giorno, mentre se ne sta seduto su una grande roccia, vede nei pressi della riva una arrabbiatissima donna vestita di bianco scendere direttamente in acqua da una barca a vela e inveire, ad altissima voce, contro i compagni di viaggio, contro uno in particolare, Ludwig, che lei non intende più sopportare.
Liza, questo è il suo nome (ma anche il titolo originario de La cagna), sbarca sull’isola per insofferenza verso gli altrui comportamenti, per distogliersene e per sfuggire alla noia. Subito le accade, però, di ritrovarsi senza soldi, senza scarpe, con un piede ferito e a zoppicare dolorante.
Disperata, si avvicina al cane e a Giorgio che la guardano incuriositi.
Lui, non solo le estrae coi denti la grossa spina dal piede sanguinante, ma se la carica sulle spalle e la porta verso la sua casa-bunker, che lei chiama “la tana”. Poi si dà ad approntarle alla bell’e meglio un paio di rudimentali scarpe, dicendo nel frattempo al cane: «Vieni, guarda e impara… Vedi l’autosufficienza, caro Melampo!».
Così intimo è il rapporto da cui son legati che, mentre il cane lo guarda amorevolmente, il padrone, non solo fa altrettanto, ma digrigna pure i denti con una canina mimica facciale. Sicché Melampo, inseparabile com’è da lui, guaisce per dispiacere, per gelosia o voglia di stare fra di loro quando Giorgio e Liza si abbracciano la prima volta.
L’indomani di buon mattino – dopo la notte d’amore – lui è già intento a ritrarla, mentre lei dorme ancora, in un disegno di cui farle dono a colazione.
Altro non resta, quindi, che ricondurla con un gommone al porto sulla terraferma.
Di nuovo solo, Giorgio ha per notturna compagnia il reiterato ascolto di Creola e il meditare su quel se stesso intento a vedere, oltre il vetro che la protegge, la riproduzione di uno dei tanti quadri di Paul Gauguin su Le donne tahitiane; così può autoritrarsi immaginandosi come un selvaggio ribelle in due disegni dal deciso tratto espressionista e che sembrano rimandare per certi versi al puntinismo del fumetto di Franco Caprioli Il mito dei mari del sud e, per altri versi, a Hugo Pratt di Corto Maltese, a quel suo inconfondibile disegnare a china da cui sortisce una peculiare figuratività essenziale.
Ma in realtà questi suoi autoritratti espressionisti sono soprattutto una magistrale sintesi di quella complessa linea evolutiva dell’arte che da Gauguin, Van Gogh, Ensor, Munch – passando per i primitivi, i fauvisti e il cubismo – approda all’espressionismo di Kirchner, Bleyl, Heckel, Marc. Perviene, cioè, all’uso intensivo e caratteristico del colore, delle linee e delle xilografie; un uso oltremodo deciso affinché ne risultino fortemente accentuate la semplificazione della forma e una insuperabile incisività espressiva fino al grottesco, con il fermo proposito di mostrare a quale grado di alienazione sia giunto un mondo moderno scientisticamente produttivo nel lavoro e aridamente disumano nei sentimenti.
Un mondo alienato insomma, al cui cospetto gli artisti si dividono in correnti fra di esse contrapposte. Se i costruttivisti e i futuristi ne fanno una entusiastica esaltazione apologetica, i postimpressionisti e gli espressionisti intendono invece separarsene.
Si distaccano infatti dal moderno in quanto tale, quindi, a partire dalle sue stesse radici; ripudiano, perciò, il classicismo rinascimentale e la raffaellesca imitazione della «natura come dovrebbe essere», ossia la natura idealizzata.
È un distacco definitivo ma necessario – da ogni forma di accademia – affinché l’arte sia libera di riscoprire il selvaggio e il primitivo. Non a caso Picasso nelle sculture africane ritrova quella inusitata potenza che lo spinge a tagliare i legami con le leggi della prospettiva e della rappresentazione; imbocca così la strada che lo porta a dipingere Les demoiselles d’Avignon e al cubismo.
Ma è solo l’inizio. Tant’è che in seguito potrà dire, anche provocatoriamente: «A quattro anni dipingevo come Raffaello, poi ho impiegato una vita per imparare a dipingere come un bambino».
In breve: dalla critica dell’idea di progresso nasce l’esigenza di un genuino atto creativo, non più mutuato dalla tradizione accademica, bensì ispirato alle cosiddette arti negre – africana, asiatica, oceanica – in una sorta di ritorno all’origine, a quella spontaneità espressiva che l’arte e la cultura europee hanno invece perduto da tempo, a causa di un progressivo intellettualismo e di un ingigantirsi della menzogna della civiltà, nonché del disagio che ne deriva.
Un’idea, questa, che risale perlomeno a Rousseau. Ma che accomuna anche Freud e Nietzsche. Al quale direttamente si ispira il gruppo espressionista Die Brücke che proprio dal Così parlò Zarathustra riprende l’immagine metaforica del Ponte: «Ciò che è grande nell’uomo è che è un ponte e non un fine».
Un ponte tra il suo più lontano passato e il presente, ma anche fra se stesso e l’oltre se stesso, ovverosia il suo essere un oltreuomo che in sé riassume il primitivo spirito dionisiaco.
In tal senso va intesa la straordinaria figura di Paul Gauguin, che segna il passaggio dall’impressionismo al postimpressionismo e apre all’arte espressionista, nel mentre in sé riaccoglie quello spirito dionisiaco che impregna profondamente sia il primitivismo sia il fauvismo. Talmente forte è il suo bisogno di riscoprire il selvaggio e l’ancestrale che – non bastandogli la fuga in Bretagna e neppure quella a Tahiti (dove gli sembra di stare quasi in Europa) – Gauguin se ne va addirittura nelle Isole Marchesi, sempre alla ricerca del primigenio: sia nel mondo esterno sia dentro e oltre se stesso.
Ed è quel che confusamente cercava Glauco nel finale di Dillinger. Ma pure quel che cerca Giorgio ne La cagna, in modo intenzionale però. Perché lui (diversamente da Glauco) ha assimilato con estrema consapevolezza tanto la lezione delle avanguardie degli inizi del Novecento quanto quella delle neoavanguardie degli Anni Sessanta. Durante i quali vi è un gran fermento di esperienze artistiche: ognuna diversa dalle altre, ma tutte capaci di interagire entro una ricca mescolanza di espressionismo astratto, di materico, di informale e perfino di neo-figurazione pop-artistica o d’altro genere.
Questa ricca mescolanza di esperienze diverse confluisce nella mirabile sintesi espressa – in chiave di fumetto – nei due disegni in cui Giorgio si autoritrae per meglio vedersi.
L’autoritratto, però, scaturisce da uno sguardo indiretto perché – nel mentre la sua immagine si riflette sul vetro della riproduzione del piccolo quadro di Gauguin – i suoi occhi pensosi non guardano il riflesso di se stesso, bensì le donne tahitiane dipinte dal grande pittore; con il cui sguardo Giorgio si identifica a tal punto da condividerne sino in fondo il desiderio di allontanarsi il più possibile dal disagio della civiltà. Tant’è vero che, nei due disegni, il suo volto ha le sembianze del selvaggio (nobilmente fiero di esserlo) e anche del cane, ma è pure contrassegnato dal truculento gesto del ribelle; questo suo volto campeggia, infatti, su una grande forbice insanguinata e su un ammasso di teste tagliate.
D’altronde, una delle storie che lui vorrebbe disegnare è quella di Spartaco, ispirandosi però espressamente a ciò che ne dice Marx: «Un grande generale dal nobile carattere: un genuino rappresentante dell’antico proletariato, giacché da ribelle si trasformò in un rivoluzionario».
Tuttavia, proprio quando crede di potersene stare sprofondato in sé e nella sua arte dentro il bunker sull’isola disabitata, ritorna Liza che, non solo gli si stringe mezza nuda, ma gli chiede di scaldarla, amarla e tenerla con sé nel letto – da dove l’assonnato Melampo scappa via.
Certo, di giorno, lei sembra decisa a lasciarlo e tornarsene sulla terraferma. In realtà, vorrebbe andarsene sol perché lui non fa che pescare o giocare con Melampo, a cui si affida così ciecamente da camminare sulle rocce a occhi bendati e stringendo nella mano il guinzaglio del cane, che lo precede e gli fa da guida.
Allora lei, in preda alla gelosia, architetta un piano per eliminare questo vero e proprio rivale in amore. Non appena Giorgio va a disegnare nel bunker, lei circuisce Melampo con sapiente dolcezza, lo chiama per nome, gli parla accarezzandolo, lo attira in acqua con femminili blandizie e movenze sinuose; giocando e scherzando nuotano insieme per un lungo tratto, così tanto al largo che l’animale muore di sfinimento.
Quando lo seppelliscono nei pressi del minuscolo cimitero, Liza e Giorgio indossano occhiali da eschimesi e lei anche il collare del povero cane. E, mentre lui si lamenta di non avere più nessuno con cui parlare, lei, non solo gli confessa di aver fatto morire Melampo, ma di volerne prendere il posto. Beve, infatti, nella sua ciotola; raccoglie il bastone del gioco e del comando per riconsegnarlo al padrone, a cui lei si sottomette leccandogli la mano come una cagna fedele. E Giorgio, digrignando i denti – tra il violento e il tenero – le cura le ferite, le accarezza la capigliatura come fosse un folto e morbido pelo canino; getta il più lontano possibile il bastone che lei, ubbidiente e gioiosa, va a raccogliere per riportarglielo indietro.
Quando, poi, se ne stanno tra le rocce a scaldarsi davanti a un falò di rami secchi, lui le parla di una vicenda accaduta in Germania più di duecento anni addietro; gliene parla con nella mente l’idea di poterla raccontare anche attraverso i disegni.
È la storia di un uomo pio, processato per aver fatto l’amore con una cagna.
Era un monaco che amava la solitudine e – mortificando la carne – aveva raggiunto la pace dei sensi, pure perché forse ambiva alla santità.
Ma un giorno incontrò una cagna molto bella. La seguì per qualche tempo finché non la perse di vista. Quando la rivide, lei fece di tutto per attirarlo; lui le andò dietro fin dentro un granaio, e lì fecero l’amore.
Si disse che il diavolo avesse preso le forme della cagna, per tentarlo. Perciò il monaco fu processato e arso vivo… e l’animale anche.
Pensosi, restano in piedi e silenti a guardare il crepitante ardere della fiamma. Poi d’un tratto lei, inginocchiandoglisi a fianco, gli lecca più e più volte la mano in segno di riconoscenza per questo simbiotico legame umano-animale, simile a quello che c’era fra Giorgio e Melampo. Al quale Liza si è sostituita per entrare financo nelle immagini archetipiche dell’inconscio di Giorgio, nel suo bisogno di soddisfare e di esprimere nella vita e nell’arte le pulsioni ancestrali di cui egli avverte l’urgere prepotente e che pure in lei risuonano e si oppongono al moderno mondo della alienazione totale.
E così sembrano assaporare, per lunghi istanti, quel ritorno a Pan di cui parla James Hillman: quell’istinto primordiale che insieme rivivono immaginando la forma metaforica delle cose. Sapendo, entrambi, che ciò che fanno nella immaginazione ha – nel profondo di loro – le medesime conseguenze del metterle in atto. Ne sentono, quindi, la potenza eversiva che li spinge a liberarsi dal carcere della civile menzogna. E lui, fortemente ispirato com’è, disegna quasi di getto la storia d’amore del “monaco” e della “cagna”, identificandosi al contempo in un novello Spartaco che con gesto espressionista spezza le catene della schiavitù al moderno mondo alienato.
Ma, non appena gli sembra di aver intuito la differenza fra ribellismo artistico e rivoluzione, arriva il figlio più grande per chiedergli di tornare a Parigi perché la madre ha tentato di suicidarsi. Sicché Giorgio, ritrovandosi di nuovo in famiglia e nella vita borghese da cui era fuggito, s’avvede di come la sua esperienza sentimentale e artistica sull’isola sia servita unicamente a produrre opere da vendere per mantenere una moglie nevrotica, la figlia minorenne che mangia solo carote in compagnia del gatto e un se stesso la cui libertà consisterebbe nello starsene seduto davanti al Café de Flore con un vecchio amico disilluso e dedito al bere, mentre entrambi con aria da intellettuali annoiati guardano, fra altri spettatori distratti, gli Hare Krishna che invitano gli astanti a conoscere Krishna: a ripetere centinaia di volte un mantra che, obnubilando il pensiero, consentirebbe di intravedere una improbabile felicità.
Ogni possibile alternativa sembra dissolversi. Il ritorno a Parigi lo riprecipita nella precedente condizione.
Senonché la cagna ha seguito il padrone: Liza gli si presenta improvvisamente in casa all’ora di pranzo e Giorgio decide di ripartire con lei. Ma non prima di aver detto alla moglie che i suoi tentati suicidi sono ricatti affettivi derivanti anche dalla incapacità – per mancanza d’immaginazione – di comprendere il perché Liza sia simbolicamente una “cagna” pur non essendo tale. E la moglie, per tutta risposta, si mette a quattro zampe sul letto e tra le lacrime gli si offre – con un supplichevole, goffo, quasi impercettibile ondeggiare del sedere – come una povera cagna in candida vestaglia. Tanto che lui, provandone pena, le sussurra quasi con affetto di non fare così.
Tornati sull’isola, i due amanti rientrano festosi nell’intimità della tana.
Però, non solo piove a dirotto e il bunker s’impregna di umidità, ma la sferza del vento porta al largo il loro gommone e ben presto si ritrovano pure senza cibo, non potendo vivere solamente di pesca. Bisogna andar via con un vecchio aereo, un residuato bellico che lui rimette a posto e ridipinge di rosa. Sembra che si levino in volo verso l’utopia… ma il film termina con il fotogramma fisso dell’aereo, prima che si stacchi da terra.
Giorgio e Liza non hanno un passato da salvare né un futuro in cui credere.
Di sicuro sono profondamente legati dall’immaginazione e dall’aver tagliato i ponti con le convenzioni sociali e l’ipocrisia borghese, ma tutto ciò a lei chissà se basta.
Per lui invece, siccome ha deciso di andare sino in fondo, significa una forma di resistenza anarchica: da ribelle che, rifuggendo la massificata società omologante e sfruttatrice, persegue la libertà – anche artistica.
In questo gesto estremo del personaggio si identifica Marco Ferreri, pur sapendo che il ribelle è diversissimo dal rivoluzionario, perché la rivoluzione non la si fa da soli e l’arte non basta. Essa, infatti, al massimo può favorire la presa di coscienza. Che però è la necessaria pre-condizione di qualsiasi tentativo rivoluzionario.
